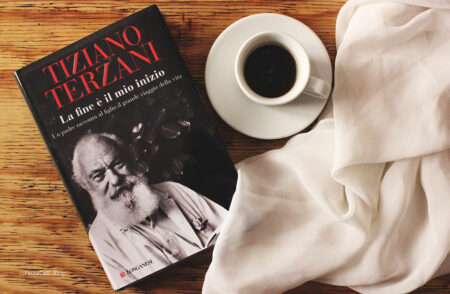Il mio paese inventato è il primo dei libri autobiografici di Isabel Allende, pubblicato nel 2003, il racconto disegna, sul filo di una memoria che aggira i fatti troppo intimi, un paesaggio interiore dove aleggiano gli spiriti dei defunti e dove i ricordi si sovrappongono senza un ordine cronologico.
“Da quando attraversai le Ande ho cominciato inconsapevolmente a inventarmi un paese.”
Come i personaggi di alcuni suoi romanzi memorabili, Isabel Allende, segnata da un doloroso senso dell’esilio, torna con il ricordo alle sue radici, a un paese ormai “inventato” e sfocato per la lunga distanza. Oggi, dopo tanta vita e tanti abbandoni, tanti libri scritti e tanta nostalgia del Cile, immaginato e sognato, custodito come paesaggio interiore e abitato dagli spiriti dei defunti, ma è anche orgoglio delle radici, il piacere di riscoprire una parte silenziosa di se stessa dentro la familiarità delle parole, la curiosità delle conversazioni, la sorpresa dei comportamenti, l’incanto dei paesaggi luminosi, il calore e l’eccentrica vitalità dei suoi compatrioti.
“Mi capita con molti episodi e aneddoti della mia vita: mi sembra di averli vissuti, ma al momento di metterli sulla carta e analizzarli razionalmente mi sembrano poco attendibili. Il problema, comunque, non mi turba. Cosa importa se sono successi davvero o se me li sono immaginati? In ogni caso, la vita è sogno.”
Isabel Allende, nata in Perù da famiglia cilena, ha sempre considerato il Cile la sua patria, anche se oltre metà della sua vita è trascorsa all’estero.
Per questo, oltre alla storia contemporanea del sudamerica, sono i ricordi nostalgici a comporre questo libro autobiografico.
Costretta a fuggire dal Cile con i due figli ed il marito si trasferì in Venezuela dopo il golpe di Pinochet, dove lo zio Salvador Allende morì vittima del colpo di Stato. Con la fama letteraria poi, si trasferisce in California col marito e guarda indietro ai suoi anni cileni, alla sua amata patria con tutte le sue stranezze e fattezze. Il romanzo è narrato in prima persona, con stile semplice, descrittivo e come sempre un po’ ironico. Non usa un ordine cronologico, bensì si lascia andare ai ricordi di vita, svelando anche ciò che di vero o alterato è narrato nei suoi libri. Infatti molto della sua vita da adolescente emerge a tratti ne La casa degli spiriti, come la figura imponente del nonno, o quella grondante della bisnonna, e anche il padre che spesso nei suoi romanzi è vissuto come una triste assenza. Spiega le tradizioni cilene, ne fa confronti con il prima e il dopo, e ne racconta aneddoti personali. Insomma in questo romanzo l’autrice narra tutto ciò che le ricorda la sua antica patria, compreso le fantasticherie che lei stessa ha creato ed ha finito per creder vere.
In questo libro l’autrice rivela che il suo libro “Il piano infinito” parla della vita di suo marito William.
“Il nonno non credeva ai germi per lo stesso motivo per cui non credeva ai fantasmi: non li aveva mai visti.”
Questo libro mi è piaciuto molto, sono innamorata del modo di scrivere della Allende, pensavo che mi sarei annoiata, invece è leggero, ironico e ti trasporta in luoghi lontani che suscitano curiosità.
Sono nata tra le nuvole di fumo e la carneficina della Seconda guerra mondiale e ho trascorso la maggior parte della mia giovinezza in attesa che qualcuno, premendo distrattamente un bottone, facesse esplodere le bombe atomiche e saltare in aria il pianeta. Nessuno sperava di vivere a lungo; andavamo di fretta, divorando ogni istante prima che ci sorprendesse l’apocalisse, perciò non c’era tempo di stare a guardarsi l’ombelico e prendere appunti, come si usa adesso. E per di più sono cresciuta a Santiago del Cile, dove qualunque naturale inclinazione autocontemplativa è stroncata sul nascere. Il motto per definire lo stile di vita di quella città è: “Chi dorme non piglia pesci”. In altre società più raffinate, come quella di Buenos Aires o New York, andare dallo psicologo era una cosa normale; non andarci era considerato un segno di ignoranza o semplicioneria. In Cile, invece, ci andavano solo i pazzi pericolosi con la camicia di forza; ma questo cambiò negli anni settanta, con la rivoluzione sessuale. Chissà che le due cose non siano collegate… Nessuno della mia famiglia è mai stato in terapia, nonostante qualcuno di noi fosse un vero caso clinico, perché l’idea di fare le proprie confidenze a uno sconosciuto – e per giunta pagarlo perché ascoltasse – era considerata assurda; per questo c’erano i preti e le zie. Non indulgo spesso alla riflessione, ma nelle ultime settimane mi sono sorpresa a ripensare al passato con una frequenza che può spiegarsi solo come un segno di senilità precoce.
A scatenare questo turbine di ricordi sono stati due episodi avvenuti di recente. Il primo è stato un commento casuale di mio nipote Alejandro che, mentre scrutavo la carta geografica delle mie rughe davanti allo specchio, ha esclamato compassionevole: “Non preoccuparti, nonna, ti restano almeno altri tre anni!”. Allora ho deciso che era giunto il momento di rivedere la mia vita, per cercare di capire come avrei desiderato trascorrere quei tre anni che tanto generosamente mi erano stati concessi. Il secondo episodio scatenante è stato la domanda di uno sconosciuto durante una conferenza di scrittori di viaggi che mi sono trovata a inaugurare. Premetto che non appartengo a quella strana categoria di gente che viaggia in luoghi lontani, sopravvive ai batteri e poi pubblica libri per convincere gli incauti a seguire le sue orme. Viaggiare è terribilmente faticoso, soprattutto dove non è previsto il servizio in camera. Le mie vacanze ideali le trascorrerei su una sdraio sotto un ombrellone nel mio giardino a leggere libri di viaggi avventurosi che non intraprenderei mai, se non per scappare da qualcosa.
Provengo dal cosiddetto Terzo mondo (qual è il Secondo?) e ho dovuto accalappiare un marito per vivere legalmente nel Primo; non ho intenzione di tornare al sottosviluppo senza una valida ragione. Tuttavia, mio malgrado, ho peregrinato per cinque continenti e ho dovuto fare l’esiliata volontaria e l’immigrante. In materia di viaggi sono un’esperta e per questo mi hanno invitato a parlare in quella conferenza. Alla fine del mio breve discorso si è alzata una mano tra il pubblico e un giovanotto mi ha domandato che ruolo giocasse la nostalgia nei miei romanzi. Per un attimo sono rimasta in silenzio. Nostalgia… secondo il dizionario è “la tristezza di trovarsi lontano dalla propria terra, la malinconia causata dal ricordo di una gioia perduta”. La domanda mi ha tolto il fiato, perché fino ad allora non mi ero resa conto che la scrittura rappresenta per me un esercizio costante della nostalgia. Sono stata forestiera per quasi tutta la vita, condizione che accetto perché non posso fare altrimenti. Diverse volte sono stata costretta a partire, sciogliendo legami e lasciandomi tutto alle spalle, per cominciare da zero in un altro posto; ho vagato per più luoghi di quanti possa ricordare. A forza di dire addio mi si sono seccate le radici e ho dovuto generarne altre che, in mancanza di un terreno in cui fissarsi, mi si sono piantate nella memoria; ma attenzione, la memoria è un labirinto dove i minotauri sono in agguato.