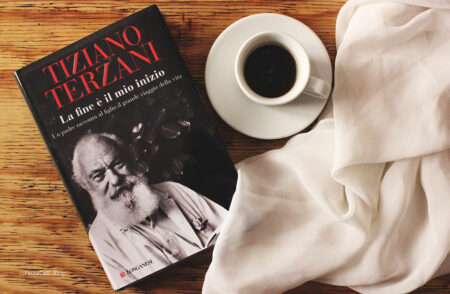L’isola sotto il mare è un romanzo di Isabel Allende, pubblicato nel 2009, col quale torna a stupire raccontando, ancora una volta, di un’eroina femminile alle prese con le intemperanze della vita.
“Aspetta, Tété. Vediamo se ci aiuti a risolvere un dubbio. Il dottor Parmentier sostiene che i neri siano umani quanto i bianchi e io dico il contrario. Tu che ne pensi?” le domandò Valmorain, in un tono che al dottore sembrò più paterno che sarcastico. Lei rimase muta, con gli occhi rivolti a terra e le mani giunte.
“Forza, Teté, rispondi senza timore. Sto aspettando…”
“Il padrone ha sempre ragione” mormorò lei in conclusione.
“In altre parole, pensi che i neri non siano completamente umani…”
“Un essere che non è umano non ha opinioni, padrone.”
Un romanzo storico che si svolge tra l’isola di Santo Domingo e la Louisiana, dal 1770 al 1810. Un personaggio femminile memorabile: Zaritè Sedella, detta Tété. Un affresco potente una storia veramente popolare nella tradizione del feuilleton, con colpi di scena, rapide virate dell’amore e soprattutto un gusto maestoso del narrare.
Le eroine di Isabel Allende recano tutte il medesimo tratto dominante: la passione. Sono le passioni a scolpirne il destino.
1770, Santo Domingo, ora Haiti. Tété ha nove anni quando il giovane francese Toulouse Valmorain la compra perché si occupi delle faccende di casa. Intorno, i campi di canna da zucchero, la calura sfibrante dell’isola, il lavoro degli schiavi. Tété impara presto com’è fatto quel mondo: la violenza dei padroni, l’ansia di libertà, i vincoli preziosi della solidarietà. Quando Valmorain si sposta nelle piantagioni della Louisiana, anche Tété deve seguirlo, ma ormai è cominciata la battaglia per la dignità, per il futuro, per l’affrancamento degli schiavi. È una battaglia lenta che si mescola al destarsi di amori e passioni, all’annodarsi di relazioni e alleanze, al muoversi febbrile dei personaggi più diversi – soldati e schiavi guerrieri, sacerdoti vudù e frati cattolici, matrone e cocottes, pirati e nobili decaduti, medici e oziosi bellimbusti. Contro il fondale animatissimo della Storia, Zarité Sedella, soprannominata Tété, spicca bella e coraggiosa, battagliera e consapevole, un’eroina modernissima che arriva da lontano a rammentarci la fede nella libertà e la dignità delle passioni.
Consiglio questo libro che la grande bravura dell’autrice ha reso scorrevole, piacevole e commovente, non sarà uno dei suoi lavori migliori, ma vale la pena leggerlo.
Nei miei quarantanni io, Zarité Sedella, ho avuto miglior fortuna di altre schiave. Vivrò a lungo e la mia vecchiaia sarà gioiosa, perché la mia stella – la mia z’étoile – brilla anche quando la notte è nuvolosa. Conosco il piacere di stare con l’uomo scelto dal mio cuore quando le sue grandi mani mi risvegliano la pelle. Ho avuto quattro figli e un nipote e quelli che sono vivi, sono liberi. Il mio primo ricordo della felicità, quando ero una mocciosa tutta ossa e dai capelli arruffati, è muovermi al ritmo dei tamburi, e questa è anche la mia più recente felicità, perché ieri sera sono stata nella piazza del Congo a ballare e ballare, senza pensieri nella testa, e oggi il mio corpo è caldo e stanco.
La musica è un vento che si trascina via gli anni, i ricordi e la paura, quell’animale acquattato che mi porto dentro. Con i tamburi scompare la Zarité di tutti i giorni e torno a essere la bambina che danzava quando a malapena sapeva camminare. Vesto per terra la pianta dei piedi e la vita mi sale lungo le gambe, percorre lo scheletro, si impossessa di me, mi libera dall’inquietudine e mi addolcisce la memoria. Il mondo rabbrividisce. Il ritmo nasce nell’isola sotto il mare, scuote la terra, mi attraversa come un lampo e se ne va in cielo portandosi via le mie pene affinché Vapa Bondye le mastichi, le ingoi per lasciarmi pulita e appagata. I tamburi vincono la paura. I tamburi sono l’eredità di mia madre, la forza della Guinea che è nel mio sangue. Nulla allora può sopraffarmi, divento devastante come Erzuli, loa dell’amore, e più veloce della frusta. Tintinnano le conchiglie alle mie caviglie e ai polsi, domandano le zucche, rispondono i tamburi djembe con la loro voce di bosco e i timpani con la loro voce di metallo, invitano i djun djun che sanno parlare e rimbomba il
grande maman quando lo colpiscono per chiamare i loa. I tamburi sono sacri, tramite loro parlano iloa.
Nella casa in cui sono cresciuta nei primi anni, i tamburi rimanevano zitti nella stanza che condividevo con Honoré, anche lui schiavo, ma Spesso uscivano a passeggio. Madame Delphine, la mia padrona di allora, non voleva sentire rumori da neri, solo i gemiti malinconici del suo clavicordo. Il lunedì e il martedì dava lezioni a ragazze di colore e il resto della settimana insegnavanelle dimore dei grands blancs, dove le signorine disponevano dei loro strumenti dato che non potevano usare quelli che suonavano anche le mulatte. Imparai a pulire i tasti con il succo di limone, ma non potevo fare musica perché madame ci proibiva di avvicinarci al suo clavicordo. Né ne avevamo bisogno. Honoré poteva far sgorgare la musica da una pentola, qualsiasi cosa nelle sue mani aveva tempo, melodia, ritmo e voce; i suoni erano nel suo corpo, li aveva portati dal Dahomey. Il mio giocattolo era una zucca vuota che facevamo suonare; in seguito mi insegnò ad accarezzare con delicatezza i suoi tamburi. E questo sin dall’inizio, da quando ancora mi doveva tenere in braccio e mi portava ai balli e ai riti vudù, in cui lui scandiva il ritmo con il tamburo principale affinché gli altri lo seguissero. Così ricordo. Honoré sembrava molto vecchio, benché a quel tempo non avesse più anni di quanti ne ho io ora, perché gli si erano raffreddate le ossa. Beveva tafia per sopportare il dolore a ogni movimento, ma più che quel liquore aspro, per lui la medicina migliore era la musica. Al suono dei tamburi, i suoi gemiti si trasformavano in risate. Honoré a malapena riusciva a pelare le patate per il pranzo della padrona con le sue mani deformi, ma quando suonava il tamburo era instancabile e se si trattava di ballare, nessuno alzava le ginocchia più in alto, né scuoteva la testa con più forza, né dimenava il culo con maggior soddisfazione. Quando non sapevo ancora camminare, mi faceva danzare da seduta, e non appena fui in grado di reggermi sulle gambe, mi invitava a perdermi nella musica come in un sogno. «Balla, balla, Zarité, perché lo schiavo che balla è libero… finché balla» mi diceva. E io ho sempre ballato.