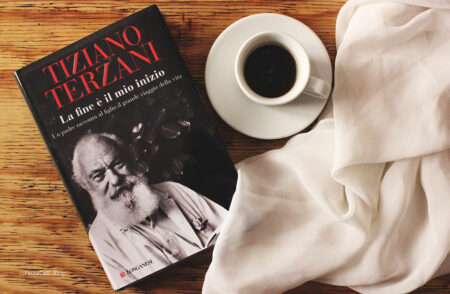Un gatto, un cappello e un nastro, sono questi gli ingredienti dei racconti racchiusi in questo libro scritto da Joanne Harris e pubblicato il 30 ottobre 2014.
Un gatto per tenermi compagnia.
Un cappello per nascondermi.
Un nastro per legare un sogno.
Che cosa porteresti con te su un’isola deserta? L’autrice di Chocolat non ha dubbi: un gatto, un cappello e un nastro. Tre oggetti in apparenza comuni che all’occorrenza sono in grado di far scaturire una miriade di immagini e di storie. Perché raccontare per Joanne Harris è un modo di affrontare la vita e le sue sfide: niente è impossibile per l’immaginazione, e se riusciamo a immaginare ci sarà sempre un finale inaspettato per ogni giorno della nostra vita.
Un gatto, un cappello e un nastro sono delle piccole perle letterarie, legate tra loro come una collezione di scatole cinesi: basta aprirne una per scoprirne mille altre, nascoste a una prima occhiata e per questo ancora più preziose.
“Una casa non è mattoni e calce. Una casa è fatta di quelle cose capaci di durare quando i mattoni e la calce non esistono più.”
Storie popolate da personaggi estremamente umani, costretti dalla vita a confrontarsi con il dolore di una perdita, con una società che non offre punti di riferimento, con lo svanire di un desiderio lungamente vagheggiato. Personaggi che nella fantasia e nella parola trovano non solo una via di fuga, ma anche una risorsa inesauribile di speranza e di forza di volontà. E il caso di Ngok e Maleki, due ragazzine africane che rifiutano di piegarsi a un destino di privazioni e decidono di seguire la voce del proprio cuore. O di Faith e Hope, due vecchiette che, escluse dalla gita al mare della casa di riposo in cui vivono, si improvvisano detective e riescono a risolvere un intrigante mistero. O di Maggie, che ha la passione dei dolci e dei biscotti, e che nella pasticceria troverà la dolcezza che la vita le ha negato. In ognuna di queste istantanee, Joanne Harris mette il lettore direttamente a contatto con la propria ispirazione, rendendolo partecipe della propria scrittura e aprendogli come mai prima d’ora il proprio cuore.
Le storie sono come le matrioska: le apri e dentro a ciascuna ne trovi un’altra. Canzone del fiume è stato scritto quando ero in Congo con Médecins Sans Frontières. Il perché mi trovassi lì è una storia in sé, ma quando ero a Brazzaville ho incontrato una banda di ragazzini che aveva escogitato un espediente ingegnoso (e pericoloso) per guadagnarsi da vivere. Si raccoglievano vicino al fiume sotto la veranda di uno dei pochi ristoranti sopravvissuti della città e, per una moneta o una manciata di avanzi, intrattenevano i clienti saltando nelle rapide nel punto più pericoloso del fiume e cavalcavano la corrente verso valle. Questi bambini – nessuno di loro aveva più di dieci anni – mettevano a rischio la propria vita decine di volte al giorno, spesso per nulla più di un osso di pollo o un pezzo di pane. E sembravano pure divertirsi.
Bene, c’è sempre il fiume. È quanto dice Maman Jeanne, con l’aria che i vecchi assumono quando parlano di qualcosa che non è possibile capire, tipo come fa un aeroplano a stare in aria o perché il Buon Dio ha creato la mosca tze-tze. È la sua risposta a ogni cosa: lamentele, domande, lacrime. Bene, c’è sempre il fiume, dice. Il fiume Congo è sempre lì.
Io dovrei saperlo: lo osservo da tutta la vita. Ne conosco gli umori; come un cane feroce che talvolta gioca, ma mira alla gola se spingi il gioco troppo in là. Conosco i punti per pescare e i posti migliori per nuotare, le rapide e le acque basse, gli isolotti e le sabbie e dove hanno ucciso l’ultimo ippopotamo, anni fa. A sentirli parlare, sembrerebbe che tutti gli abitanti di Brazzaville fossero presenti quel giorno: fosse così, quel vecchio ippopotamo dovrebbe trovarsi proprio lì nella Bibbia, accanto al miracolo del foufou e dei pesci. Tuttavia, dice Maman Jeanne, pescatori e cacciatori sono nati per mentire.
Forse è il fiume che glielo fa fare.
È vero che qui le storie si raccolgono. Come il giacinto d’acqua, dal nord galleggiano fino a valle, si separano e fioriscono a mano a mano che passano. La storia delle tre Streghe, o del Ragazzo Aquila o del Pesce Diavolo, così enorme da poter spezzare con i denti la spina dorsale di un ippopotamo o da inghiottire un coccodrillo in un sol boccone. Questo, almeno, è vero; ho un dente di pesce diavolo che lo dimostra, scambiato (per una sigaretta e mezza barretta di gomma da masticare) con un ragazzo su una delle chiatte. Più lungo del mio dito, lo indosso intorno al collo appeso a un filo di metallo. Maman Jeanne dice che non dovrei: c’è della magia cattiva nel dente di un pesce diavolo, e comunque non è opportuno che una ragazzina di dieci anni ciondoli attorno a quelle chiatte sul fiume.
Se lei fosse mia madre, dice Maman Jeanne, mi insegnerebbe a cucinare, a cucire e a sistemare i capelli con le treccine in un’acconciatura geometrica per acchiappare un uomo. «È questo che dovresti pescare, ragazza», dice, «non qualche vecchio pesce diavolo che non potresti mangiare nemmeno se lo tirassi su.» Ma io sono capace di badare a me stessa, e non devo fare quello che dice Maman Jeanne. E poi, come dice lei, la gente può andare e venire, ma il fiume è sempre lì.