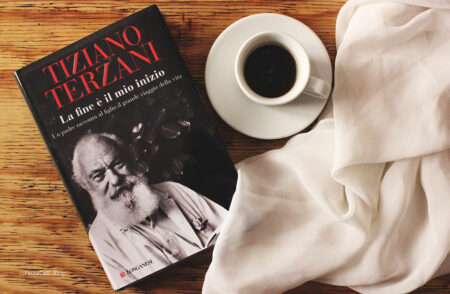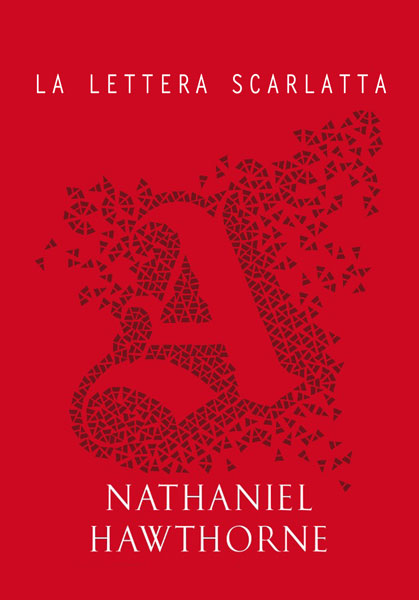
La lettera scarlatta è un classico della letteratura statunitense scritto da Nathaniel Hawthorne, fu pubblicato nel 1850, tutt’oggi rimane uno dei libri più venduti in America, oltre ad essere uno dei più importanti della letteratura americana del diciannovesimo secolo.
Il libro narra la storia di Hester Prynne, una donna che viene condannata per adulterio e costretta a portare sulla sua veste una “A” scarlatta come simbolo del suo peccato.
I temi centrali dell’opera sono la colpa e il peccato, il concetto di moralità e l’idea di riscatto sociale inseriti in un contesto puritano dell’epoca.
“Esiste una fatalità, un sentimento cosí irresistibile e inevitabile da assumere la forza di un destino, il quale, quasi invariabilmente, obbliga gli esseri umani ad attardarsi, ad abitar come spettri le prossimità del luogo, dove qualche solenne e indimenticabile evento abbia conferito il suo colore a tutta la loro vita; e questa forza è tanto piú irresistibile quanto piú cupa l’ombra che affligge la vita loro.”
Nathaniel Hawthorne (il vero nome era Hathorne) era un figlio di Salem, discendente di quella dura e intransigente schiatta di puritani che emigrarono dalla natia Inghilterra per fondare nuove comunità sul continente americano. I suoi antenati furono uomini di fede integerrima e pugno di ferro, tanto da essere direttamente coinvolti nella grande caccia alle streghe della cittadina americana.
Lo scrittore portò sempre con sé il rimorso per le azioni dei propri antenati, tanto da dedicare alle sventurate vittime di tanta durezza un romanzo che divenne il suo biglietto d’ingresso nella Storia della Letteratura.
“Il popolo è dispotico per natura; spesso rifiuta di rendere giustizia a chi la reclami troppo strenuamente come suo diritto, ma quasi altrettanto spesso dà più che la semplice giustizia quando si faccia appello, come piace ai tiranni, alla sua sola generosità.”
Il romanzo è ambientato nel New England puritano nel XVII secolo e racconta la storia di una donna che mette al mondo una figlia durante l’assenza del marito. Hester Prynne, questo il suo nome, rifiuta di rivelare alla comunità puritana del New England il nome del padre della bambina e tenterà, con grande fatica e senso di colpa, di recuperare la propria dignità attraverso il pentimento.
Viene esposta sul palco della gogna cittadina, ed è costretta a portare ricamata sul petto una rossa lettera «A», simbolo del suo peccato. Accanto a lei, l’anziano marito che si mette ossessivamente a caccia del colpevole, e il giovane reverendo Arthur Dimmesdale che soffre del suo peccato ma è troppo orgoglioso per confessarlo.
La lettera scarlatta è incorniciata da un’introduzione (chiamata “La dogana”) nella quale lo scrittore, un alter ego di Hawthorne, finge di aver trovato documenti e carte che raccontano la storia di Prynne e ne provano l’autenticità. Il narratore sostiene anche che quando toccò la lettera ricamata (trovata assieme alle carte) aveva provato “un calore bruciante … come se la lettera non fosse di panno scarlatto, ma di ferro arroventato fino a diventare rosso”. In precedenza Hawthorne aveva lavorato nella Dogana di Salem per lungo tempo, perdendo il proprio lavoro a causa di un cambiamento dell’amministrazione politica.
“Bisogna riconoscere un merito alla natura umana: quando non è in gioco l’interesse personale, è molto più pronta ad amare che a odiare.”
Il romanzo esplora temi profondi come la colpa, il pentimento, la morale e l’ipocrisia della società puritana. Hester Prynne diventa un simbolo vivente del peccato agli occhi della comunità, ma allo stesso tempo manifesta una forza interiore e un senso di indipendenza che sfida le convenzioni sociali dell’epoca.
Al centro della vicenda c’è anche il personaggio del reverendo Arthur Dimmesdale, il padre del bambino illegittimo di Hester. Dimmesdale, tormentato dalla sua colpa segreta, combatte una lotta interiore tra il desiderio di confessare il suo peccato e la paura di essere giudicato dalla comunità.
Attraverso la storia di Hester, Dimmesdale e degli altri personaggi, Hawthorne indaga la natura del peccato e della redenzione, mettendo in discussione l’etica e la moralità della società puritana. Il romanzo esplora anche il ruolo delle donne nella società e l’oppressione che spesso subiscono.
Un libro che solo per la sua fama dovrebbe essere letto, detto questo, purtroppo ho faticato a leggerlo. Ho cominciato questo libro più volte, l’introduzione di circa cinquanta pagine mi uccideva di noia e fa pensare che tutto il romanzo sia così, ma non lo è. Quindi, consigliata da molti, mi sono fatta coraggio ed ho proseguito la lettura, ma la situazione è migliorata di poco, l’aggettivo che mi viene in mente è “ripetitivo”, fino allo sfinimento.
Un romanzo che non fa per me. Resta comunque un libro con una scrittura interessante e sul messaggio morale non si discute. Ho odiato la descrizione della piccola Pearl, ripetuta e ripetuta quasi in ogni capitolo. Alla fine la parte che più mi è piaciuta per l’originalità è proprio l’introduzione “La dogana”.
Incipit del libro “La lettera scarlatta”
E’ abbastanza curioso che, per quanto sia restio a parlare eccessivamente di me stesso e dei miei affari accanto al caminetto e agli amici più intimi, per la seconda volta in vita mia, nel rivolgermi al pubblico, io abbia ceduto a un istinto autobiografico. La prima volta fu tre o quattro anni fa, quando gratificai il lettore, ingiustificabilmente e senza una ragione plausibile che il lettore indulgente o l’importuno scrittore potessero immaginare, di una descrizione della vita che conducevo nella profonda quiete di un vecchio presbitero. E ora, poiché, malgrado le mie scarse doti quella volta fui così fortunato da trovare un paio d’ascoltatori, agguanto nuovamente il pubblico per il bavero della giacca per narrargli i miei tre anni di esperienza in un ufficio doganale. L’esempio del famoso “P.P., chierico di questa parrocchia” non fu mai seguito con maggior fedeltà. Pare dunque che la verità sia che, quando l’autore sparge i suoi fogli al vento, egli non si rivolga ai tanti che getteranno in disparte il suo libro per non interessarsene più, ma ai pochi che saranno in grado di capirlo meglio di quasi tutti i suoi compagni di scuola e di vita. Alcuni autori, del resto, si spingono ancora più in là, e si abbandonano a confidenze così profondamente rivelatrici che si dovrebbero fare, solo ed esclusivamente, all’unico cuore e spirito capaci di perfetta comprensione, come se il libro stampato, gettato allo sbaraglio nel vasto mondo, dovesse per forza trovare la parte disgiunta della natura dell’autore, e ne completasse l’esistenza ponendolo in intimo contatto con essa.
Anche parlando impersonalmente, però, non è decoroso dire tutto.
Giacché i pensieri, d’altra parte, restano gelati e incomunicabili, a meno che non si stabilisca una reciproca comprensione tra l’oratore e il pubblico, è ammissibile immaginare che un amico, cortese e perspicace, anche se non sia il più intimo, ci stia ad ascoltare: solo allora, vinta la naturale ritrosia da questa confortante consapevolezza, potremo discorrere di quel che accade attorno a noi, e addirittura di noi stessi, pur mantenendo velato il nostro Io più intimo. A queste condizioni ed entro questi limiti un autore può, secondo me, essere autobiografico, senza calpestare né i suoi diritti né quelli del lettore.Si vedrà poi come questo schizzo della Dogana abbia un’attinenza, di una sorta che ha sempre avuto diritto di cittadinanza nella letteratura, con il resto del libro, perché spiega come la maggior parte delle pagine seguenti sia entrata in mio possesso e fornisce le prove dell’autenticità del racconto che contengono. E’ questo in realtà, e nessun altro, il vero motivo per cui mi metto personalmente in rapporto col pubblico: il desiderio di pormi nella mia vera veste di curatore, o poco più, del più prolisso dei racconti che costituiscono il mio libro. Nel seguire questo scopo principale mi è sembrato lecito dare, con pochi tocchi di mio pugno, un pallido ritratto di un genere di vita che finora non era mai stato descritto e di alcuni dei personaggi che ne fanno parte, uno dei quali s’è trovato a essere l’autore.
Nella mia città natale, Salem, si trovava cinquant’anni fa, ai tempi del vecchio King Derby, un molo pieno di movimento, ma che oggi è soffocato da magazzini di legno in rovina, e mostra pochi o nessun segno di vita commerciale, eccetto forse una goletta a palo o un brigantino attraccati a metà della sua malinconica lunghezza, che scaricano pelli; o, più vicino, una goletta della Nuova Scozia, che scarica legna da ardere; all’estremità, dico, di questo molo in rovina, che spesso la marea inonda, e lungo il quale, alla base e sul retro della fila di edifici, le tracce di molti noiosi anni si scorgono su un margine di stentate erbe, c’è una spaziosa costruzione di mattoni, dalle cui finestre anteriori si può ammirare questo poco allegro panorama e tutto il porto. Sul punto più elevato del tetto, esattamente per tre ore e mezzo ogni mattina, sventola o pende, col vento o la bonaccia, la bandiera della repubblica, ma con le tredici strisce disposte verticalmente invece che orizzontalmente, a indicare che il governo dello zio Sam ha destinato l’edificio a usi civili e non militari. La facciata si adorna di un portico di una mezza dozzina di pilastri di legno che reggono un terrazzo, sotto cui una rampa di ampi gradini di granito scende verso la strada. Sulla porta d’ingresso si protende un enorme esemplare dell’aquila americana con le ali spiegate, uno scudo sul petto e, se ricordo bene, un mazzo di saette mischiate assieme e di frecce acuminate in ciascun artiglio. Con l’abituale brutto carattere che distingue questo sfortunato volatile sembra che, con la ferocia insita nel becco e negli occhi e, nel complesso, con il suo atteggiamento truculento, minacci guai a tutta la pacifica comunità, e soprattutto pare che voglia avvertire ogni cittadino, al quale stia a cuore la propria incolumità, di non entrare nello stabile che essa protegge con l’ombra delle sue ali. Malgrado ciò, per rabbiosa che sembri, molti in questo stesso momento stanno cercando riparo sotto le ali dell’aquila federale, credendo, immagino, che il suo petto abbia la morbidezza e la comodità di un guanciale di piume di struzzo.Ma anche nei momenti migliori l’aquila non è mai affettuosa, e presto o tardi, – e di solito più presto che tardi – finisce col gettar fuori la sua nidiata con un colpo dei suoi artigli, una beccata, o una dolorosa ferita delle sue frecce acuminate.
…
Al secondo piano della Dogana c’è uno stanzone dove i mattoni e le spoglie intelaiature di legno non sono mai stati ricoperti né intonacati. L’edificio, progettato in origine secondo dimensioni adeguate alla prosperità di cui aveva goduto il porto, e con una previsione di attività futura che non si sarebbe mai concretata, racchiude molto più spazio di quanto ne serva ai suoi occupanti.
Questo ampio salone, sopra le stanze dell’esattore, è rimasto fino a oggi incompiuto e, malgrado le vecchie ragnatele che ne decorano le intelaiature polverose, sembra aspettare ancora l’opera del carpentiere e del muratore. A un’estremità della stanza, in un ripostiglio, si trovavano dei barili accatastati, pieni di fasci di documenti ufficiali. Pacchi di simili scartoffie ingombravano il pavimento, ed era triste pensare a quanti giorni, settimane, mesi e anni d’attenzione erano stati sprecati su quei fogli ammuffiti, i quali ora non erano che un impiccio sulla terra, e se ne stavano nascosti in quell’angolo appartato dove nessun occhio umano li avrebbe mai più visti. Ma in fondo, quali altri patrimoni letterari – non certo scritti con l’aridità della formalità d’ufficio, ma con l’immaginazione di cervelli fantasiosi e con le ricchezze di cuori sensibili erano caduti egualmente nell’oblio e, quel che è peggio, senza ottenere lo scopo che avevano raggiunto quelle carte ammonticchiate; e, più tristemente ancora, senza neppure procurare ai loro autori la comoda vita che veniva agli impiegati della Dogana dall’imbrattare le loro inutili carte! Non del tutto inutili, poi, come documenti di storia locale. Qui
indubbiamente si sarebbe potuto scoprire statistiche dell’antico commercio di Salem e memorie dei suoi potenti mercanti, il vecchio King Derby, il vecchio Billy Gray, il vecchio Simon Forrester e di molti altri magnati del tempo andato: le loro teste incipriate si erano appena posate nella tomba che i loro patrimoni avevano cominciato a scemare. Qui si potrebbero rintracciare i capostipiti della maggior parte delle famiglie che ora compongono l’aristocrazia di Salem, dai modesti e oscuri inizi dei loro traffici, in tempi di solito molto posteriori alla rivoluzione, fino al raggiungimento di una posizione che i loro discendenti considerano ormai ben consolidata.
Prima della rivoluzione c’è una lacuna nei documenti, probabilmente perché gli atti e gli archivi della Dogana furono trasportati a Halifax quando tutti i funzionari del re seguirono l’esercito britannico nella sua fuga da Boston. Me ne sono rammaricato spesso, perché se quelle carte si fossero spinte indietro fino, diciamo, ai giorni del protettorato, avrebbero potuto contenere molti riferimenti a uomini noti o dimenticati, e ad antiche costumanze, che mi avrebbero dato la stessa gioia che provavo quando raccoglievo punte di frecce indiane nel campo vicino al vecchio presbiterio.
Ma, un giorno triste e piovigginoso, ebbi la fortuna di fare una scoperta di un certo interesse. Frugando e
scavando tra queste scartoffie ammucchiate nell’angolo, aprendo ora l’uno ora l’altro documento e leggendo i nomi dei vascelli che molti anni prima erano sprofondati nell’oceano o erano marciti all’attracco, e quelli di mercanti di cui in Borsa oggi non si sente più parlare, che il tempo ha reso difficilmente decifrabili sulle loro stesse pietre tombali; scorrendo dunque queste cose con quell’interesse triste, stanco e quasi riluttante che suscitano in noi le spoglie di un’attività ormai defunta – ed esercitando la mia fantasia, impigrita dalla lunga inazione, nel cercare di ricreare con quelle vecchie ossa l’immagine dei giorni migliori della vecchia città, quando l’India era un paese nuovo, e soltanto Salem conosceva la rotta verso di essa, – mi capitò in mano un pacchetto, avvolto con cura in un pezzo di vecchia pergamena gialla. Questo pacco aveva l’aria di un documento ufficiale di un’epoca assai lontana, quando gli impiegati ricoprivano della loro calligrafia rigida e formale materiali più consistenti di quelli d’oggi. C’era in esso qualcosa che solleticava la mia curiosità istintiva e che mi costrinse a
sciogliere lo sbiadito nastro rosso che lo legava, con la sensazione che ci fosse dentro un tesoro da riportare alla luce.
Scartando le rigide falde dell’involucro, trovai che si trattava della nomina, di pugno del governatore Shirley e col suo sigillo, di un tale Jonathan Pue, a sovrintendente della Dogana di Sua Maestà per il porto di Salem, nella provincia della Baia del Massachusetts. Ricordai d’aver letto (forse negli “Annals” di Felt) la notizia del decesso del signor sovrintendente Pue, circa ottant’anni prima; e anche un giornale, in tempi recenti, portava il resoconto della riesumazione dei suoi resti nel piccolo cimitero della chiesa di Saint Peter, durante un restauro dell’edificio.…
Ma quel che attrasse con più forza la mia attenzione per il pacchetto misterioso fu un oggetto di prezioso tessuto rosso molto consunto e sbiadito. In esso si potevano ancora vedere tracce di ricami d’oro, che però erano molto malridotti e talmente scoloriti che dell’originario luccicchìo nulla restava, o almeno molto poco. Era facile vedere che era opera di una ricamatrice abilissima, e il punto (come mi hanno assicurato delle signore iniziate a questi misteri) testimonia un’arte ormai scomparsa, che non potrebbe essere riscoperta neppure disfacendone i fili. Questo straccio di stoffa rossa, perché il tempo, l’uso e la tarma sacrilega lo avevano ridotto a poco più di uno straccio, assumeva, a un più attento esame, la forma di una lettera. Era una A maiuscola. Una misurazione accurata dimostrò che ogni asta era lunga tre pollici e un quarto. Era chiaro che si era voluto farne un articolo di vestiario, un ornamento, ma come dovesse essere portato, quale rango, carica o dignità comportasse in passato, era un rebus che (tanto sono effimere le passioni del mondo per questi particolari) non avevo molte speranze di risolvere. La lettera serbava per me uno strano interesse, e vecchia e scarlatta com’era, i miei occhi si fissavano su di essa e non riuscivano a staccarsene. Certo doveva esserci in essa qualche profondo significato, che ben sarebbe valso le fatiche di un’interpretazione, e che, allo stato attuale, aveva per me qualcosa del simbolo mistico, che si comunicava impercettibilmente ai miei sensi, ma sfuggiva all’analisi della mia mente.
Rimuginando tra me questi pensieri, e vagliando, tra le altre possibilità, quella che la lettera fosse una di quelle decorazioni che i bianchi indossavano per fare effetto agli indiani, me l’appoggiai casualmente sul petto. Mi parve allora, rida pure il lettore, ma non dubiti della mia parola, mi parve di provare una sensazione, per nulla fisica, ma tuttavia quasi corporea, di un calore bruciante, come se la lettera non fosse stata di stoffa, ma di ferro rovente. Rabbrividii, e involontariamente la lasciai cadere a terra.
Assorto nella contemplazione della lettera scarlatta non mi ero curato fino a quel momento di esaminare il rotolino di carta ingiallita attorno al quale essa era avvolta. Lo aprii dunque, ed ebbi la soddisfazione di scoprire una spiegazione quasi completa di tutta la storia di mano del vecchio sovrintendente. Erano parecchi fogli protocollo che contenevano molti particolari concernenti la vita e l’adulterio di una certa Hester Prynne, che sembrava essere stata un personaggio notevole agli occhi dei nostri antenati. Il periodo in cui si erano svolti i fatti in questione andava dai primi tempi della colonizzazione del Massachusetts alla fine del diciassettesimo secolo. Al tempo del signor sovrintendente Pue erano ancora in vita dei vecchi, dalla cui testimonianza egli aveva ricavato la sua storia, che la ricordavano, all’epoca della loro giovinezza, come una donna molto anziana, ma non decrepita, di portamento nobile e solenne. Da tempo immemorabile aveva preso l’abitudine di girare il paese come una specie di infermiera volontaria, e di fare del bene in ogni modo e in ogni forma le fosse possibile, non risparmiandosi neppure la fatica di dare consigli in ogni campo, e soprattutto in quello sentimentale, così da acquistarsi (com’è inevitabile che succeda a chi faccia altrettanto) la venerazione e la fama di angelo presso molti, ma, credo, quella di importuna e di noiosa presso altri. Studiando ulteriormente il singolare manoscritto vi scoprii il racconto di altre azioni e di altre sofferenze di questa donna straordinaria, la
maggior parte delle quali il lettore potrà trovare nella storia intitolata “La lettera scarlatta”; e bisogna sempre ricordarsi che i fatti principali di questa storia hanno i crismi e l’autenticazione del signor sovrintendente Pue. Il manoscritto originale e la stessa lettera scarlatta, reliquia veramente insolita, sono ancora in mio possesso, e sarò lieto di mostrarli a chiunque sia stato spinto dall’interesse presentato dal mio racconto al desiderio di vederli. Non voglio dire di essermi limitato, nella stesura dell’opera e nella descrizione dei sentimenti e delle passioni che spinsero ad agire i personaggi che vi compaiono, alla mezza dozzina di fogli protocollo del vecchio sovrintendente; al contrario, mi sono permesso in questo campo quasi o del tutto la stessa libertà di cui mi sarei servito se i fatti fossero stati frutto della mia immaginazione. Insisto soltanto sull’autenticità dell’abbozzo.
Questo avvenimento riportò in parte i miei pensieri sulla vecchia strada. Mi parve di avere trovato un buon soggetto per un romanzo.…
Alla storia di Hester Prynne, quindi, dedicai molto studio. Fu l’oggetto delle mie meditazioni per molte ore, mentre misuravo a grandi passi la mia stanza da un capo all’altro, o compivo per la centesima volta il lungo tragitto tra la porta principale della Dogana e l’ingresso laterale, e viceversa. Era grande l’insofferenza e la noia del vecchio ispettore, dei pesatori e dei misuratori, i cui pisolini erano disturbati dallo spietato rimbombo dei miei passi concitati all’andata e al ritorno: essi fecero appello alle loro antiche abitudini, e cominciarono a dire che il sovrintendente passeggiava sul cassero. Credevano probabilmente che il mio unico scopo (e, certo, il solo per il quale un uomo sano di mente potesse mettersi in moto di sua spontanea volontà) fosse di farmi venire appetito per il pranzo; e, a dire il vero, un certo appetito, aguzzato dal vento di levante che molto spesso soffiava nel corridoio, era l’unico risultato apprezzabile di tanto indefesso esercizio. L’atmosfera di una Dogana è così poco adatta ai frutti delicati della fantasia e della sensibilità che anche se ci fossi rimasto per altre dieci presidenze, non credo che il racconto de “La lettera scarlatta” sarebbe mai stato presentato al pubblico. La mia immaginazione era uno specchio appannato: non riusciva a riflettere, o rifletteva solo con deplorevole opacità, le immagini con le quali studiavo di popolarla. I personaggi del romanzo non si arroventavano e non diventavano malleabili a dispetto di ogni fuoco che riuscissi ad attizzare nella mia fucina intellettuale. Non acquistavano né il calore della passione né la tenerezza del sentimento, ma serbavano tutta la rigidità di cadaveri, e mi contemplavano con uno spettrale sogghigno di sfida. “Che cosa hai tu da spartire con noi?” sembrava dire quell’espressione. “Quell’ombra di poteri che una volta esercitavi sulla stirpe delle immagini è ormai scomparsa! Sei tu che l’hai barattata per una manciata di denaro pubblico: vattene a guadagnare il tuo stipendio!”. Insomma, le torpide larve della mia stessa fantasia mi schernivano e mi davano dell’imbecille, e non senza buone ragioni.
Da questo romanzo sono stati tratti parecchi film:
1926 – La lettera rossa, regia di Victor Sjöström, con Lillian Gish e Lars Hanson
1934 – The Scarlet Letter, regia di Robert G. Vignola, con Colleen Moore e Hardie Albright
1973 – La lettera scarlatta, regia di Wim Wenders, con Senta Berger
1995 – La lettera scarlatta, regia di Roland Joffé, con Demi Moore, Gary Oldman e Robert Duvall.
Se vuoi ACQUISTA il libro