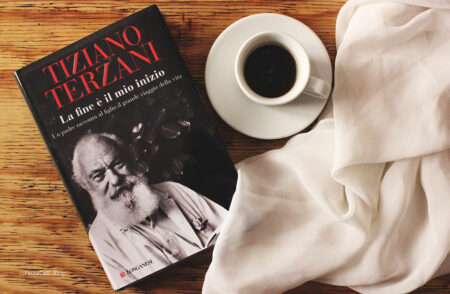La mia Africa è un libro autobiografico della danese Karen Blixen, pubblicato da Feltrinelli e tradotto da Lucia Drudi Demby. Ci racconta gli anni trascorsi in Africa, nella sua fattoria, dentro una piantagione di caffè, alle pendici dell’altipiano del Ngong, in Kenya. Arrivò in Africa nel 1913 e la lasciò per sempre tornando in Danimarca nel 1931. Il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1937 ed è una dichiarazione d’amore per questa terra, per la sua gente, i Kikuyu, i Masai, i Somali.
“Io conosco il canto dell’Africa, della giraffa e della luna nuova africana distesa sul suo dorso, degli aratri nei campi e delle facce sudate delle raccoglitrici di caffè. Ma l’Africa conosce il mio canto? L’aria sulla pianura fremerà un colore che io ho avuto su di me? E i bambini inventeranno un gioco nel quale ci sia il mio nome? O la luna piena farà un’ombra sulla ghiaia del viale che mi assomigli? E le aquile sulle colline Ngong guarderanno se ci sono?”
Karen Blixen ha descritto con una limpidezza senza pari il suo rapporto d’amore con l’Africa. Sovranamente digiuna di politica, ci ha dato il ritratto forse più bello del continente nero, della sua natura, dei suoi colori, dei suoi abitanti. I Kikuyu che nulla più può stupire, i fieri e appassionati Somali del deserto, i Masai che guardano, dalla loro riserva di prigionieri in cui sono condannati a estinguersi, l’avanzata di una civiltà “che nel profondo del loro cuore odiano più di qualsiasi cosa al mondo”. Uomini, alberi, animali si compongono nelle pagine della Blixen in arabeschi non evasivi, in una fitta trama di descrizioni e sensazioni che, oltre il loro valore documentario, rimandano alla saggezza favolosa di questa grande scrittrice, influenzando in modo determinante i contenuti della sua arte.
“I bianchi cercano in tutti i modi di proteggersi dall’ignoto e dagli assalti del fato; l’indigeno, invece, considera il destino un amico, perché è nelle sue mani da sempre; per lui, in un certo senso, è la sua casa, l’oscurità familiare della capanna, il solco profondo delle sue radici”.
Se avete visto il celebre adattamento cinematografico del 1985, diretto da Sydney Pollack, con Meryl Streep e Robert Redford, che ha vinto ben 7 Premi Oscar, scordatelo, dimenticate la storia d’amore con Denis Finch-Atton, le uniche cose in comune tra le due opere sono la forza e il coraggio di una donna e la magnificenza del paesaggio.
“L’Africa, fra tutti i continenti, insegna questo: che Dio e il Diavolo sono uno, la maestà coeterna, non due increati ma un solo increato: gli indigeni non dividevano la sostanza, ma non confondevano le persone.”
 La narrazione non ha una trama, come succede nella letteratura da viaggio, si susseguono meravigliose descrizioni di paesaggi, aneddoti di vita, incontri nuovi e vecchi che animano la fattoria. Si può tranquillamente immaginare Karen Blixen lontana dalla sua terra che cerca di raccontare la sua Africa piano piano che i ricordi affiorano. Un racconto che ci parla della feroce bellezza di questa terra, nonostante i cambiamenti inflitti dai coloni, senza mai giudicare la realtà storica in cui viveva. Non si è mai esposta, mai una critica alla colonizzazione selvaggia, ma si è limitata a raccontare la sua esperienza come un ospite in un paese che apparteneva ad altri popoli.
La narrazione non ha una trama, come succede nella letteratura da viaggio, si susseguono meravigliose descrizioni di paesaggi, aneddoti di vita, incontri nuovi e vecchi che animano la fattoria. Si può tranquillamente immaginare Karen Blixen lontana dalla sua terra che cerca di raccontare la sua Africa piano piano che i ricordi affiorano. Un racconto che ci parla della feroce bellezza di questa terra, nonostante i cambiamenti inflitti dai coloni, senza mai giudicare la realtà storica in cui viveva. Non si è mai esposta, mai una critica alla colonizzazione selvaggia, ma si è limitata a raccontare la sua esperienza come un ospite in un paese che apparteneva ad altri popoli.
“Di fronte al curioso, istintivo attaccamento che tutti gli indigeni avevano per Berkeley e Denys e per pochi altri come loro, mi chiedevo se, in un’altra epoca, in qualsiasi altra epoca, in realtà, non sarebbero esistite fra i bianchi e la gente di colore un’intesa e una comprensione che noi ora, nell’era dell’industria, non potevamo raggiungere. Con la prima macchina a vapore le strade delle razze umane si separarono: da allora non si sono riunite mai più.”
 Mi ha colpito molto la personalità di questa donna, intraprendente e ribelle, che da sola ha affrontato situazioni difficili e complesse, lontane dal nostro mondo, il suo senso di avventura era davvero invidiabile, ma sapeva essere anche concreta e decisa.
Mi ha colpito molto la personalità di questa donna, intraprendente e ribelle, che da sola ha affrontato situazioni difficili e complesse, lontane dal nostro mondo, il suo senso di avventura era davvero invidiabile, ma sapeva essere anche concreta e decisa.
Nonostante la delusione iniziale nel rendermi conto che non era ciò che mi aspettavo, ho affrontato la lettura comunque con entusiasmo, a parte qualche racconto, soprattutto il commovente finale, e le indubbie riflessioni che scaturiscono dalla rappresentazione di quella realtà, non mi ha catturato più di tanto, anche se l’Africa mi affascina e qualche passo resterà con me per sempre.
“V’era un tratto del suo carattere per me veramente prezioso: amava sentir raccontare. Io, per parte mia, avrei dovuto nascere ai tempi della peste in Firenze. Ora i gusti sono mutati, si è perduta l’arte dell’ascoltare, in Europa. Gli africani la posseggono ancora perché non sanno leggere. Appena principi a dire: “Un tale camminava nella pianura e incontrò un altro”, subito pendono dalle tue labbra, subito la loro fantasia insegue con slancio la pista sconosciuta dei due uomini sulla pianura. Ma i bianchi non son più capaci di prestar orecchio a un racconto, nemmeno se sentono che è loro dovere. Divengono irrequieti, si ricordano di mille incombenze da sbrigare proprio in quel momento; se, addirittura, non si addormentano. Le stesse persone, invece, son capaci di cercare qualcosa da leggere e di trascorrere tutta la sera immerse nella lettura di un qualsiasi pezzo di carta stampata. Riescono persino a leggere i discorsi. È l’abitudine di cogliere le cose solo con gli occhi.
Denys, che era molto sensibile alle impressioni uditive, preferiva sentir raccontare una storia piuttosto che leggerla. Quando veniva alla fattoria mi chiedeva: “C’è una storia per me?” Io ne avevo preparate tante, durante la sua assenza.”

In Africa la sua casa è diventata museo e tutta la zona di Nairobi oggi è il «quartiere Karen»: caffè, ristoranti, lodge, persino l’ospedale e il centro commerciale portano il suo nome della Leonessa Blixen.
“… non ero io ad andarmene, io non avevo il potere di lasciare l’Africa, ma era l’Africa che lentamente, gravemente si ritirava da me, come il mare nella bassa marea.”
1
LA FATTORIA SULLA COLLINAIn Africa avevo una fattoria ai piedi degli altipiani del Ngong. A un centocinquanta chilometri più a nord su quegli altipiani passava l’equatore; eravamo a milleottocento metri sul livello del mare. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al sole, ma i mattini, come la sera, erano limpidi e calmi, e di notte faceva freddo.
La posizione geografica e l’altezza contribuivano a creare un paesaggio unico al mondo. Nulla che fosse grasso e lussureggiante: era un’Africa distillata lungo tutti i suoi milleottocento metri di altitudine, quasi l’essenza forte e raffinata di un continente. I colori, asciutti ed arsi, parevano colori di terracotta. Gli alberi avevano un fogliame delicato e leggero, di una struttura diversa da quelli d’Europa: non si curvava in archi e cupole, ma si tendeva in strati orizzontali, il che dava agli alberi, alti e solitari, l’aspetto un po’ delle palme, o un piglio eroico e romantico di navi tutte attrezzate e pronte a partire, ma con le vele non ancora spiegate: e al margine dei boschi un’apparenza strana, come se l’intero bosco vibrasse leggermente. Nelle grandi pianure crescevano, sparsi, i vecchi spineti nudi e torti, l’erba aveva l’odore pungente del timo e del mirto delle paludi: in certi punti il profumo era così forte da far dolere le narici. Tutti i fiori che sbocciavano sui prati o fra i rampicanti e le liane della foresta, erano piccolini come quelli dei bassopiani; soltanto all’inizio delle grandi piogge spuntavano gigli monumentali, dal profumo pesante. Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema.
Il tratto più caratteristico del paesaggio, e della vita lassù, era l’aria. Ricordando un periodo passato sugli altipiani d’Africa, si ha la sensazione sconcertante di essere vissuti nell’aria. Il cielo era di solito celeste pallido o violetto, solcato da nubi maestose, senza peso, in continuo mutamento, erte come torri; ma aveva in sé un tale vigore d’azzurro da colorare anche i boschi, e le colline accanto, di una tinta fresca e profonda.
Nel pieno del giorno l’aria, in alto, era viva come una fiamma: scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre, specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava, la mattina, sugli altipiani, e si pensava: “Eccomi qui, è questo il mio posto”.
Si trovano anche racconti di caccia, di safari con lo scopo di uccidere animali per farne trofeo, come il racconto che segue, che un po’ mi hanno turbata, anche se con la mente comprendo il modo di pensare dell’epoca e di certi contesti, col cuore trovo la caccia come sport una bruttura del nostro mondo.
Kanuthia, il giovane servo di Denys, seduto dietro, mi sfiorò la spalla indicando qualcosa, alla nostra destra. Sul bordo della strada, a circa dodici metri, una massa scura, un’enorme testuggine riposava sulla sabbia; qualcosa si agitava sulla sua testa, nell’acqua bruna. Era, lo vidi dopo, una giraffa maschio, uccisa probabilmente da qualche giorno. La legge proibiva di sparare alle giraffe: quella volta finimmo per venir incolpati noi. Per fortuna potemmo dimostrare d’averla trovata già morta, ma non si seppe mai chi l’avesse uccisa e perché. Accovacciata sulla enorme carogna, una leonessa la stava sbranando: sollevò la testa per guardare la nostra macchina.
Denys si fermò. Kanuthia si sfilò dalla spalla la carabina. Denys mi chiese sottovoce: “Posso sparare?” La sua cortesia giungeva fino a fargli quasi considerare la collina del Ngong un mio terreno di caccia privato. Ci trovavamo nella terra dei masai venuti a lamentarsi per la perdita del bestiame: forse il caso ci aveva condotti proprio dinanzi alla leonessa che faceva strage delle loro mucche e dei loro vitelli. Era giunto il momento di por fine alla sua esistenza. Annuii.
Denys saltò giù dalla macchina arretrando rapidamente di qualche passo; nel momento stesso in cui la belva scompariva con un tuffo dietro alla giraffa egli, aggirata la carogna, l’aveva già a tiro. Sparò, ma non vidi la leonessa cadere: quando scesi e mi avvicinai giaceva a terra, morta, in una grande pozza nera.
Non avevamo il tempo di scuoiarla. Dovevamo ripartire subito se volevamo raggiungere il safari. Ci guardammo intorno per ricordare il punto dove ci trovavamo, ma sarebbe stato impossibile passarvi accanto senza accorgersene, tanto era il fetore della giraffa morta.
Percorsi altri tre chilometri la strada si interruppe. Al limite giacevano gli attrezzi degli operai: al di là solo la vasta distesa pietrosa, grigia nell’alba, non toccata dalla mano dell’uomo. Guardammo gli attrezzi e la pietraia: non potevamo evitare che l’amico di Denys corresse i suoi rischi con la carabina. Più tardi sapemmo che fortunatamente non ebbe mai occasione di usarla. Tornammo indietro; il cielo, a levante, stava tingendosi tutto di rosso, sulla pianura e sulle colline. Lungo la strada non facemmo che parlare della leonessa.
La giraffa ricomparve all’orizzonte. Adesso la distinguevamo bene: sul fianco, dove batteva la luce, si scorgevano le macchie quadrate, più scure, sul suo pelo. Avvicinandoci, ci accorgemmo che ora le incombeva addosso un leone. La belva le stava proprio sopra, tutta nera: dal basso, la vedevamo stagliarsi contro il cielo in fiamme. Lion Passant Or. Il vento gli sollevava la criniera. Balzai in piedi, nella macchina, tanto era forte l’effetto. Denys disse: “Spara tu, questa volta”. Non ero mai stata molto brava a maneggiare la sua carabina, troppo lunga e pesante, per me, e con un rinculo troppo violento. Ma la fucilata, quella volta, era una dichiarazione d’amore: come avrebbe potuto partire da un fucile di minor calibro? Quando sparai mi parve che il leone balzasse in aria e ricadesse con le zampe prone sotto il ventre. Rimasi ansante nell’erba. Ardevo dal senso di onnipotenza che dà una fucilata a chi ne scorga gli effetti a distanza. Girai intorno alla carogna. Ecco: avevo assistito al quinto atto di una tragedia classica. Ora erano morti tutti. La giraffa era enorme, austera, mostrava le quattro zampe rigide, il lungo collo rigido, il ventre squarciato dalle zanne dei leoni. La leonessa, riversa sul dorso, aveva un ghigno sprezzante: si sarebbe detta la femme fatale della tragedia. Il leone le giaceva accanto. Perché mai la sorte toccata alla sua compagna non gli era servita d’esempio? La testa abbandonata sulle zampe davanti, la potente criniera simile ad un manto regale, era immerso anche lui in una grossa pozza che ora, nella luce chiara del mattino, non pareva più nera ma scarlatta.
Denys e Kanuthia si rimboccarono le maniche e cominciarono a scuoiare le due belve. Stava sorgendo il sole. Quando fecero una sosta presi la bottiglia di bordeaux, l’uva e le mandorle portate per celebrare l’anno nuovo durante il viaggio. Ci sedemmo sull’erba, a mangiare e a bere. I leoni uccisi, lì accanto, apparivano stupendi nella loro nudità. Non un solo filo di grasso ricopriva i muscoli tesi, arcuati, precisi. Non avevan bisogno di manto: nulla mancava alla loro perfezione.
Se vuoi ACQUISTA il libro
Fonti:
https://www.kenyavacanze.org/safari/ngong-hills/
https://www.kenyavacanze.org/notizie/denys-finch-hatton/
https://blixen.dk/life-writings/karen-blixens-life/karen-blixen-in-africa/?lang=en