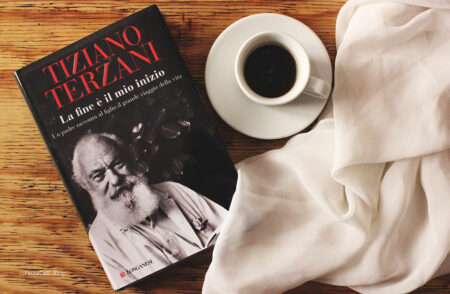Via col vento è un romanzo scritto da Margaret Mitchell, pubblicato nel 1936, fu un caso editoriale senza precedenti e vinse il Premio Pulitzer nel 1937. Un affresco storico della Guerra americana di Secessione, vista dalla parte dei sudisti, degli sconfitti. Un romanzo complesso che unisce storia, romanticismo, e tanto altro.
“Ma perché, Rhett, si fanno le guerre? Sarebbe stato meglio che gli yankees avessero pagato per i negri… o che noi li avessimo liberati, piuttosto che far succedere questo! –
– Non si tratta dei negri, Rossella. Quello non è che un pretesto. Le guerre ci sono sempre state perché gli uomini le amano. Le donne no, ma gli uomini… sì, più di quanto non amino le donne.”
1961. Rossella O’Hara (Scarlett nell’originale) è la viziata e capricciosa ereditiera di Tara, una grande piantagione di cotone, in Georgia. E’ una sedicenne egoista ed opportunista, le piace solo essere ammirata e corteggiata da tutti i ragazzi della contea e non le importa nulla dello spettro della guerra che aleggia minaccioso. Follemente innamorata di Ashley Wilkes, che non la ricambia, anzi si fidanza con la dolce cugina Melania Hamilton.
Cercando di conquistarlo, Rossella gli dichiara il suo amore proprio durante la festa del fidanzamento, ma Ashley, pur attratto dalla bellezza di Rossella, la rifiuta, sono troppo diversi e lui le vuole bene come una sorella. Ed è qui che Rossella, sola e furente di rabbia, incontra l’affascinante avventuriero Rhett Butler.
L’illusione di una vita facile e agiata si infrange in brevissimo tempo, i venti della guerra civile spirano sul sud degli Stati Uniti, così Ashley e Melania anticipano il matrimonio e Rossela, folle di gelosia, si butta tra le braccia di Charles Hamilton, fratello di Melania, e lo sposa. Il ragazzo parte subito per la guerra e muore al fronte. Rossella, incinta, mette al mondo un figlio e si trasferisce ad Atlanta con la cugina Melania, dove darà scandalo per il suo comportamento non dignitoso per una vedova e qui incontra nuovamente l’odioso Rhett Butler. Siamo solo all’inizio della storia e fermo il racconto per rispetto di chi non la conosce, non voglio rovinare la piacevole lettura.
“Te lo dico io. Perché noi ci pieghiamo di fronte all’inevitabile. Noi non siamo come l’avena che quando è matura si irrigidisce e non si piega secondo il vento; siamo come il granturco che ondeggia, e quando il vento è passato si rialza dritto e forte quasi come prima. Non siamo gente rigida. Siamo flessibili se il vento soffia forte, perchè sappiamo che in quel caso è una buona cosa essere flessibili. Quando arrivano le avversità ci chiniamo all’inevitabile senza protestare, e lavoriamo, sorridiamo e aspettiamo che torni il momento favorevole. E ci adattiamo a gente inferiore a noi, prendendo da loro ciò che di buono hanno. E, quando siamo nuovamente forti, diamo un calcio alle persone di fronte alla quali ci siamo piegati. Questo è il segreto per sopravvivere.”
Una scrittura piacevole e scorrevole ci trascima tra le 1100 pagine di questo romanzo che scivola via con facilità. Un romanzo senza tempo, molto complesso, com’è complessa anche la sua protagonista Rossella O’Hara, la giovane capricciosa e viziata, incapace, come il suo popolo, di riconoscere la sconfitta anche quando se la trova di fronte e che affronta le avversità con spirito di conquista ripetendo “ci penserò domani”.
“In quei giorni aveva imparato a scacciare i pensieri sgraditi. Si era abituata a dirsi: “Adesso non indugerò su questo e quel problema. Ci penserò domani”. E in genere, l’indomani, o quel pensiero non le si presentava alla mente o era tanto sbiadito dal tempo trascorso che non le causava grandi ansie.”
Le descrizioni sono ricche e fluide, i personaggi sono approfonditi e pieni di vita e di multiple dimensioni. Non è solo la storia d’amore che ci è stata raccontata, ma ci porta nei complicati tempi della guerra, toccando vari temi tutti degni di riflessione, come l’amicizia, la lealtà, il patriottismo, il rapporto dell’uomo con la sopravvivenza, la condizione della donna, le convenzioni sociali. L’autrice non dà giudizi storico-politici, però quello che mi ha un po’ urtato è stato l’uso liberale di termini razzialmente offensivi e la rappresentazione di schiavi felici, ma poi ho riflettuto che loro vedevano davvero la realtà in quel modo ed è così che è stata rappresentata, se lo avesse fatto in altro modo lo avrebbe falsificato. E questo fa riflettere molto sulla Banalità del male (titoto del saggio della filosofa Hannah Arendt che si chiedeva: “una persona può fare del male senza essere malvagia?”.
In questo libro viene totalmente ignorato il genocidio prodotto dalla schiavitù in America, però ci fa vedere anche l’altra parte della medaglia delle guerre di liberazione, la speculazione e il paradosso degli orrori compiuti anche da chi lotta per il bene e l’uguaglianza di altri uomini. Credo che la grande e sola protagonista di questo romanzo sia la guerra, e che questo alla fine sia un romanzo contro la guerra.
“La battaglia è come lo champagne: dà alla testa tanto ai codardi quanto agli eroi. Qualunque imbecille può diventare temerario sul campo di battaglia quando l’alternativa è essere coraggioso o farsi ammazzare.”
Si racconta che Margaret Mitchell, da adolescente, recitò travestita da eroico membro del Ku Klux Klan. Suo nonno e il suo bisnonno avevano entrambi fatto parte dell’esercito confederato. Molti dei libri che leggeva da bambina raffiguravano i bianchi del Sud come vittime degli yankee occupatori e degli schiavi liberati. E’ stata nutrita fin da bambina con i luoghi comuni della Lost Cause (il nome con cui si indica il movimento nostalgico di ideologia negazionista del “vecchio Sud” che si propone di difendere e riabilitare l’immagine della Confederazione). Si racconta pure che durante la sua breve vita (morì a quarantotto anni, uccisa da un guidatore ubriaco) finanziò diverse borse di studio per la facoltà di Medicina di una delle università storicamente nere di Atlanta, finanziò un pronto soccorso per i neri dell’unico ospedale pubblico di Atlanta. Finché Mitchell fu in vita, nessuno seppe di queste donazioni. Il suo autista, un uomo di colore, era incaricato di consegnare grosse buste di denaro a singole persone, se fosse circolata la voce della sua generosità molto probabilmente non sarebbe stata ben vista nella sua comunità. Non sapremo mai quale fosse realmente il suo pensiero, era razzista?
“Sapeva per esperienza che il bugiardo è il più ardente difensore della propria sincerità, il codardo del proprio coraggio, il villano della propria signorilità, il farabutto del proprio onore.”
 Dal romanzo è stato tratto l’epico film “Via col vento“, diretto da Victor Fleming e interpretato da Clark Gable, nel ruolo di Rhett e Vivien Leigh, in quello di Rossella O’Hara.
Dal romanzo è stato tratto l’epico film “Via col vento“, diretto da Victor Fleming e interpretato da Clark Gable, nel ruolo di Rhett e Vivien Leigh, in quello di Rossella O’Hara.
Fu proiettato per la prima volta ad Atlanta il 15 dicembre 1939. Nel 1940 vinse 10 Premi Oscar (all’epoca un record), tra cui miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior attrice (Leigh) e miglior attrice non protagonista (Hattie McDaniel, prima afroamericana a vincere un Oscar). E’ il film col maggiore incasso nella storia del cinema pertutto il XXI secolo.
Tre citazioni del film, presenti anche nel libro, sono divenute famose da essere citate spesso:
“Francamente me ne infischio” di Clark Gable;
“Dopotutto, domani è un altro giorno” di Vivien Leigh;
“Lo giuro davanti a Dio… non soffrirò mai più la fame” di Vivien Leigh.
Consiglio di vedere Il documentario della Rai di Alberto Angela “L’America di “Via col Vento“, tratto dal proramma “Ulisse: il piacere della scoperta“.
Rossella O’ Hara non era una bellezza; ma raramente gli uomini se ne accorgevano quando, come i gemelli Tarleton, subivano il suo fascino. Nel suo volto si fondevano in modo troppo evidente i lineamenti delicati della madre – un’aristocratica della Costa, oriunda francese – con quelli rudi del padre, un florido irlandese. Ma era un viso che, col suo mento aguzzo e le mascelle quadrate, non passava inosservato. Gli occhi verde chiaro, senza sfumature nocciola, ombreggiati da ciglia nere e folte, avevano gli angoli volti leggermente all’insù. Le sopracciglia nere e folte piegavano anch’esse verso l’alto, tracciando una strana linea obliqua sulla sua candida pelle di magnolia – quella pelle così apprezzata dalle donne del Mezzogiorno, che la riparano con infinita cura dai raggi ardenti del sole della Georgia mediante cuffie, veli e mezzi guanti.
Seduta tra Stuart e Brent Tarleton, in quel chiaro pomeriggio d’aprile del 1861, nell’ombra fresca del porticato di Tara, la piantagione di suo padre, ella formava davvero un grazioso quadretto.
Il suo abito nuovo di mussolina verde a fiori si allargava in pieghe ondeggianti sulla gonna a cerchi ed armonizzava a perfezione con le scarpine di marocchino verde dal tacco basso che suo padre le aveva portato recentemente da Atlanta. L’abito fasciava mirabilmente il vitino di quaranta centimetri di circonferenza, il più sottile nelle tre contee, e disegnava il seno, abbastanza maturo per i suoi sedici anni.
Malgrado la castità dell’amplissima gonna, la semplicità con cui i capelli erano intrecciati e raccolti in un nodo, la compostezza delle bianche mani congiunte nel grembo, la sua vera personalità non riusciva a celarsi. Gli occhi verdi erano vivacissimi nel visino dolce, pieni di volontà, avidi di vita, in assoluto contrasto col suo contegno riservato. Questo derivava dagli affettuosi consigli materni e dalla severa disciplina della bambinaia; ma gli occhi erano suoi ed erano indipendenti.
Seduti a fianco della fanciulla, i gemelli stavano comodamente appoggiati alle spalliere delle loro sedie; socchiudevano alla luce del sole gli occhi muniti di occhiali montati in metallo e ridevano e chiacchieravano incrociando pigramente le lunghe gambe dai saldi muscoli di cavalcatori. Avevano diciannove anni, erano alti un metro e novanta; coi volti abbronzati e i capelli fulvi, gli occhi dall’espressione gaia e arrogante, vestiti di identiche giacche turchine e calzoni da cavalcare color mostarda si somigliavano come due piante di cotone.
Fuori, il sole del tardo pomeriggio scendeva all’orizzonte e illuminava il cortile avvolgendo in una gloria di raggi gli alberi di corniolo che formavano solide masse di fiori bianchi su uno sfondo verde tenero. I cavalli dei gemelli, due grossi animali rossicci come i capelli dei loro padroni, zampavano sulla strada maestra; attorno a loro squittiva e saltellava la muta dei veltri magri e nervosi che accompagnava Stuart e Brent dovunque andassero. Un po’ in disparte, con aria aristocratica, era sdraiato un grosso cane da pastore, che, col muso posato sulle zampe anteriori, aspettava pazientemente che i giovanotti andassero a casa per la cena.
Fra i cani, i due cavalli e i due gemelli era un’affinità più profonda di quella derivante dall’essere sempre insieme. Erano tutti giovani animali sani, spensierati, graziosi e vivaci; i ragazzi focosi e temerari come i loro cavalli ma, con tutto ciò, docili e ubbidienti con chi sapeva come trattarli.
Benché fossero nati fra le agiatezze della vita della piantagione e fossero stati serviti in tutto e per tutto sin dall’infanzia, i volti dei tre giovani seduti sotto al porticato non avevano l’aspetto languido né molle. Avevano piuttosto il vigore e la vivacità di coloro che hanno passato tutta la vita all’aria aperta e non si sono troppo occupati di malinconia e di libri. La vita nella contea di Clayton nella Georgia settentrionale era ancora agli inizi, né aveva lo sviluppo già raggiunto in Augusta, Savannah, Charleston.
Le provincie meridionali più vecchie e più tranquille guardavano con un certo disdegno gli abitanti di quella parte della regione che confinava coi loro paesi; ma qui, nella parte settentrionale, la mancanza di certe finezze dell’educazione classica non era considerata una vergogna, purché questa fosse compensata dall’abilità nelle cose che più importavano. E queste erano: il coltivare del buon cotone, saper cavalcare, ballare con leggerezza, tirare al bersaglio, inchinarsi alle signore con eleganza e comportarsi come un gentiluomo di fronte ai liquori. Tutte cose in cui i gemelli eccellevano: ed essi erano ugualmente saldi nella loro notoria incapacità ad apprendere qualunque cosa fosse contenuta fra le pagine di un libro. La loro famiglia aveva più danaro, più cavalli e più schiavi di qualsiasi altra nel paese; ma i ragazzi avevano meno nozioni grammaticali di quante ne avesse la maggior parte dei loro poveri vicini.
Questa la ragione per cui Stuart e Brent poltrivano sotto il porticato di Tara in quel pomeriggio d’aprile.