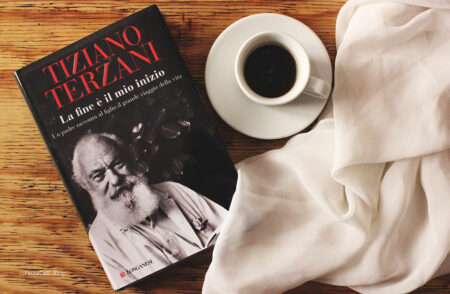Non dimenticarlo mai è un romanzo di Federica Bosco, pubblicato il 21 ottobre 2021 da Garzanti. Alla soglia dei cinquant’anni spesso si fanno bilanci sulla propria vita e potrebbe presentarsi un pensiero, una domanda: È troppo tardi per desiderare un figlio?
“Non è mai troppo tardi per prendere una decisione folle se ti rende felice”
La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo sgabello della cucina a bere un caffè e, mentre contempla la nebbia dell’inverno milanese, viene travolta da un attacco di panico in piena regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con una vita scandita da mille impegni, avverte all’improvviso la consapevolezza che la sua esistenza così com’è sembra non avere più alcun senso. Un compagno da quattro anni, Massimo, anch’egli giornalista con una forte propensione all’indipendenza, una madre giocatrice incallita dalla personalità crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le spalle, qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro amatissimo, un padre artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l’impellente desiderio di maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che adesso le sembra l’unica ragione di vita. Le reazioni delle persone vicino a lei non sono incoraggianti e, accompagnata da un coro di «ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza difficoltà a convincere il compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la fertilità, ispirata da un’idea di famiglia in cui crede ancora nonostante la sua infanzia passata a giocare a Barbie sotto i tavoli verdi. Massimo però si rivela un partner imprevedibile, che la porta un giorno in un paradiso di mille premure e quello dopo nell’inferno dell’indifferenza, facendola sentire ancora più sola. Così Giulia, quasi senza alleati, decide di abbandonare per sempre la sua zona di confort e di spiccare un salto nel vuoto.
“Era come essere usciti dal cast di una serie televisiva che andava avanti da anni e rendersi conto che avevi vissuto in un allestimento scenico, un Truman Show in tutto e per tutto.
Non avevo interagito con una persona, ma con un personaggio, un personaggio di fantasia. La mia probabilmente.”
Le recensioni sono molto positive per questo romanzo attuale, che mescolata emozioni moderne a quelle antiche, che commuove. Un libro sulla maternità, ma anche sulla dipendenza emotiva, sui rapporti tossici. Non è mai troppo tardi per volersi bene, per ricominciare.
1.
Si dice che quando stai per morire ti passi tutta la vita davanti e che, in un millesimo di secondo, ogni singolo frame importante ti appaia come sullo schermo di un cinema: le facce di tutti quelli che hai amato, le cose che hai fatto, ogni momento felice e degno di nota che hai vissuto. Tutto si sussegue in rapida successione come nel trailer di un film.
Ma le scene tagliate dal regista – i fallimenti, i rimpianti, i rimorsi, gli errori – quelle non aspettano che tu precipiti in un burrone per presentarsi, no, quelle ti vengono a trovare una mattina qualunque, mentre, appollaiata sul solito sgabello della cucina, ti bevi il solito caffè, nella solita tazza.
E il problema è che una volta che si sono manifestati non hai nemmeno la consolazione di morire, e dirti «pazienza sarà per la prossima volta», no, una volta che ti hanno recapitato il messaggio a sorpresa, come il mandato di comparizione nei film americani, non ti resta che aprire la busta e constatare che la tua vita è tutta una serie di eventi più o meno casuali, tenuti insieme da qualcosa che più che alla coerenza somiglia alla forza d’inerzia.
E non puoi fare altro che rimanere a fissare il muro, con la tazza in mano, chiedendoti che cosa hai fatto di rilevante fin qui.
Ed è quello che mi successe la mattina del mio quarantanovesimo compleanno.
Mi alzai, mi preparai il caffè e improvvisamente la mia esistenza mi sembrò del tutto vuota e priva di significato.
Come quando, da ragazzina, tua madre spalancava le tende facendo entrare la luce a illuminare la tua cameretta che ti accorgevi essere un disastro assoluto fra letto sfatto e vestiti per terra. Solo che non sei più un’adolescente da ben oltre un quarto di secolo e, guardandoti intorno, ti chiedi come hai fatto a vivere in quel casino senza accorgertene e perché nessuno ti abbia detto di mettere in ordine prima.
Un casino fatto di scadenze continue, viaggi, alberghi, conferenze stampa, riunioni che un tempo chiamavi «emancipazione» e che aveva un’aria così glamour, mentre adesso somiglia solo al mal di testa il mattino dopo una sbronza colossale e la realtà ti fissa dal divano con il sopracciglio alzato ricordandoti che la festa è finita.
Facevo la giornalista di costume, avevo un padre e una madre separati da tempo immemore, un fratellastro che amavo molto e un compagno da quattro anni, anch’egli giornalista, con cui non avevamo mai deciso di andare a convivere per via dei nostri orari e per una certa propensione all’indipendenza.
In fin dei conti, il mio epitaffio era tutto lì.
Che altro c’era da dire di rilevante?
Avevo salvato il mondo? No.
Avevo vinto il Pulitzer? Nemmeno. Risolto un conflitto internazionale? Figuriamoci, non ero nemmeno riuscita a risolvere il conflitto fra i miei e, anche a voler abbassare l’asticella, non mi veniva in mente niente di rilevante.
Un obiettivo raggiunto, una prova superata, qualcosa che segnasse una svolta importante fra le tappe della mia vita.
E non per sfoggiare chissà quale titolo o vittoria, sia chiaro, soltanto per me stessa. Qualcosa di cui andare intimamente fiera, qualcosa per cui dirmi sottovoce: «Brava ragazza, hai fatto veramente un buon lavoro, pat, pat!».
Avevo vissuto fin lì una vita che, agli occhi di tutti, poteva dirsi realizzata e forse anche invidiabile, ma che ai miei di occhi, sembrava solo il lunghissimo ripetersi di uno schema che mi aveva permesso di non pensare, di non crescere, se non anagraficamente, e di non cambiare una virgola per crearmi un’illusione di sicurezza e di immortalità.
Ecco cosa mi sconvolse quel giorno: la consapevolezza chiara, lucida e precisa che non avevo più nessuna voglia di quella vita lì, che non ne volevo più nemmeno un boccone, mi nauseava, mi stava facendo scoppiare, come avessi mangiato torta a pranzo e a cena per quasi cinquant’anni.
E non mi piacevano nemmeno le torte!
Mi sentivo confusa e vulnerabile, lì in piedi davanti alla finestra della cucina, nel freddo dell’inverno milanese che tanto mi piaceva con le sue nebbie e quel suo caos produttivo, ma che adesso mi sembrava un’enorme ruota di criceto in cui tutti correvamo.
Ma dove correvamo?
Qual era lo scopo finale se non fuggire da qualcosa?
Me lo ero mai chiesto?
Appoggiai la tazza nel lavandino e mi sedetti alla scrivania in preda a quello che, secondo Google, era un attacco di panico in piena regola: sudorazione intensa, palpitazioni, sensazione di soffocamento, vertigini, difficoltà respiratoria e un terrore cieco, come se qualcuno mi risucchiasse in un buco nero trascinandomi per i capelli.
Andai in bagno a sciacquarmi la faccia e mi guardai allo specchio: ero bianca come un fantasma.
Se fossi morta in quel momento, come tutto mi faceva credere, che cosa avrei lasciato al mondo? Qualche intervista a un attore spocchioso? Un paio di premi? I miei sette cactus?
Chi ero io? A chi appartenevo? Dov’erano le mie radici? La mia discendenza? La mia famiglia?
Dov’erano i miei figli?
Questa fu la frase che mi fece gelare il sangue e non a causa dell’attacco di panico.
No, questa era paura vera, reale, motivata.
Dove. Erano. I. Miei. Figli.
Semplice. Non c’erano.
E non c’erano perché non li avevo avuti, e non li avevo avuti perché non li avevo voluti.
Fino a dieci minuti prima.
Quando ancora c’era tempo per le cose definitive, quando aspettavo l’istinto materno che non arrivava mai o l’uomo perfetto con cui metter su famiglia, mentre tutte le mie amiche si riproducevano senza sosta tanto da perdere il conto.
E io intanto lavoravo. Mi congratulavo con loro e lavoravo, andavo ai battesimi e lavoravo, compravo tutine e lavoravo.
E mi dicevo che quella roba lì non faceva per me, che non ero il tipo, che se mi toglievano un’ora di sonno o lo spritz per nove mesi avrei fatto una strage, che tutta la faccenda del parto non l’avrei mai superata, i punti, l’allattamento, no per carità, e poi dai, mica tutte dobbiamo fare figli, no?
Si può essere madri in un altro modo.
No, non si può.
E quella mattina piansi tutte le lacrime che tenevo in serbo per le grandi occasioni.
Quelle millesimate.
Come una signora di mezza età che realizza di aver perso il treno più importante della sua vita.
E quel treno cominciò a sembrarmi l’unica ragione della mia.