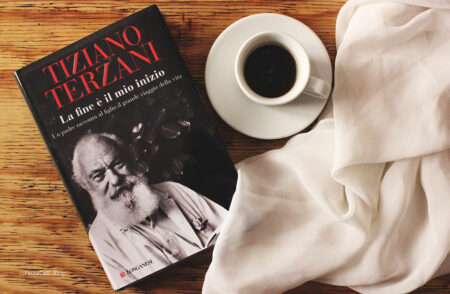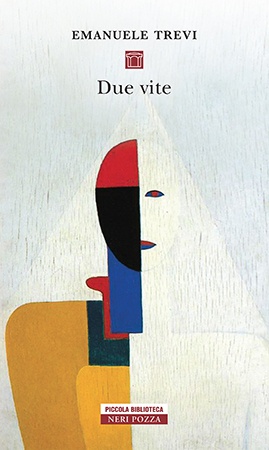
Due vite è un libro scritto da Emanuele Trevi, pubblicato nel 2020 da Neri Pozza e vincitore del Premio Strega 2021. L’autore con una ricerca fondata sulla memoria e con affetto tratteggia e omaggia le vite di due amici e scrittori italiani: Rocco Carbone e Pia Pera.
«L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unicità».
La trama di “Due vite”
Il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, così propensa alle illusioni.
Ne ridisegna i tratti: la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo; l’aspetto da incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche le differenti condotte: l’ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore.
Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell’unicità di questo libro non stanno nell’impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno attorno a uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la letteratura: l’amicizia.
Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco Carbone e Pia Pera appaiono, in queste pagine, come uniti da un legame fino all’ultimo trasparente e felice, quel legame che accade quando «Eros, quell’ozioso infame, non ci mette lo zampino».
“Da pochi mesi ho compiuto l’età esatta in cui Pia si è ammalata, cominciando a perdere progressivamente, inesorabilmente, giorno dopo giorno, l’uso del suo corpo. Gli anni di Rocco, invece, ormai li ho superati abbondantemente. I nostri amici sono anche questo, rappresentazioni delle epoche della vita che attraversiamo come navigando in un arcipelago dove arriviamo a doppiare promontori che ci sembravano lontanissimi, rimanendo sempre più soli, non riuscendo a intuire nulla dello scoglio dove toccherà a noi, una buona volta, andare a sbattere.”
Recensione
E’ la storia di tre amici, perché l’autore diventa il terzo protagonista mentre racconta di questa amicizia, dei rapporti autentici che superano la prova del tempo, estrapolando da questi due scrittori, l’immagine di un uomo e una donna reali con i loro pregi e difetti, come ognuno di noi, raccontando dei successi e delle sconfitte, i litigi e le riappacificazioni, le storie d’amore, i viaggi e le serate trascorse insieme. Racconta anche senza parlarne del dolore della perdita.
“Noi viviamo due vite, entrambe destinate a finire: la prima è la vita fisica, fatta di sangue e respiro, la seconda è quella che si svolge nella mente di chi ci ha voluto bene. E quando anche l’ultima persona che ci ha conosciuto da vicino muore, ebbene, allora davvero noi ci dissolviamo, evaporiamo, e inizia la grande e interminabile festa del Nulla, dove gli aculei della mancanza non possono più pungere nessuno.”
Il testo è breve, sole 128 pagine, ma molto intenso, con una scrittura semplice e priva di fronzoli. Forse per comprenderlo al meglio avrei dovuto conoscere le opere dei due autori. E’ stata una lettura intima, come essere capitata per caso seduta su una panchina accanto ad uno sconosciuto che ti racconta qualcosa, che ti racconta di qualcuno, e la sua malinconia diventa parte di te e te la porti a casa.
E anche quando col tempo quella malinconica si scioglie, ogni tanto ritorni su quella panchina a riflettere su chi resta e su chi va via, su ricordi: perduti, lasciati e indispensabili. Non so se è stato meritato o no il premio ricevuto, io racconto solo le emozioni che una lettura mi provoca, sicuramente è un libro che doveva essere scritto.
Rocco Carbone è nato a Reggio Calabria, il 20 febbraio 1962. Originario di Cosoleto si laurea in lettere a Roma presso l’Università degli Studi La Sapienza, con una tesi su I Malavoglia di Verga e vince un dottorato di ricerca presso l’Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne.
Si dedica alla critica letteraria per poi approdare, poco più che trentenne, alla narrativa. Nel 1993 esordisce con il romanzo Agosto, nel quale si caratterizza subito per una prosa lucida e straniante. Nel 1996 viene pubblicato Il comando, seguito nel 1998 da L’Assedio, nel 2002 da L’Apparizione e nel 2005 da Libera i miei nemici, sofferta analisi psicologica che declina il tema del terrorismo con quello più privato di un complesso rapporto tra fratelli. Pubblica articoli e racconti sulle riviste Nuovi Argomenti, Linea d’ombra, Paragone e L’indice. Collabora alla Repubblica, L’Unità e a Il Messaggero.
Nel 1998 decide di rinunciare alla carriera universitaria per insegnare presso la scuola femminile del carcere romano di Rebibbia. Mentre sta preparando l’uscita del suo ultimo lavoro, Per il tuo bene, muore a Roma in un incidente stradale a bordo della sua moto nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2008. Il romanzo uscirà poi postumo nel 2009.
“L’infelicità. E i suoi gaddiani gomitoli di concause. Parlare della vita di Rocco significa necessariamente parlare della sua infelicità, e ammettere che faceva parte della schiera predestinata dei nati sotto Saturno. Ma come definire ciò di cui soffriva Rocco? Volendo far coincidere esattamente un nome alla cosa, alla fine bisognerebbe coniare un nuovo termine, tipo «rocchite», «rocchìasi». Ma a che servirebbe? Più ti avvicini a un individuo, più assomiglia a un quadro impressionista, o a un muro scorticato dal tempo e dalle intemperie: diventa insomma un coagulo di macchie insensate, di grumi, di tracce indecifrabili.”
Pia Pera è nata a Lucca, il 12 marzo 1956, figlia del giuslavorista Giuseppe Pera, e della filosofa Elvira Genzone Pera, fu allieva di Isabel de Madariaga: divenne quindi professoressa di letteratura russa all’università di Trento, svolgendo in pari tempo attività di traduttrice dal russo di autori classici e contemporanei.
Tradusse l’Eugenio Onegin di Puškin e Un eroe del nostro tempo di Michail Lermontov. Scrisse vari libri di narrativa e saggistica e negli ultimi anni anche di giardinaggio, arte a cui si era appassionata e di cui curò una rubrica settimanale sulla rivista Diario e la rubrica apprendista di felicità sul mensile Gardenia, dal 2007 fino alla morte. Malata dal 2012 di sclerosi laterale amiotrofica, morì il 26 luglio 2016 all’età di 60 anni.
“Nel fondo dell’anima di Pia, anche nei momenti più difficili e disperati, resisteva sempre una vocazione inestirpabile ad accudire, proteggere – esseri umani, animali, vegetali. E quel gesto protettivo catturato dalla foto le è così connaturato che assomiglia più al respiro e al battito del cuore che alle decisioni consapevoli. Solo così, vorrei aggiungere, quando fare il bene è una cosa che letteralmente ti scappa, mentre nemmeno ci pensi, la mano arriva al momento giusto e scongiura il peggio. Paragonato a questo istinto morale, il bene volontario produce sempre il suono di una moneta fasulla. Non voglio assolutamente suggerire che Pia fosse una santa. Quando per lei è arrivato il momento, ha rivelato enormi riserve di saggezza e forza d’animo, combattendo bene la sua battaglia, ma nemmeno questo ha a che fare con la santità. Era semmai una persona intensa, dotata di un’anima prensile e sensibile, incline all’illusione, facile a risentirsi.”
Incipit di “Due vite”
Era una di quelle persone destinate ad assomigliare, sempre di più con l’andare del tempo, al proprio nome. Fenomeno inspiegabile, ma non così raro. Rocco Carbone suona, in effetti, come una perizia geologica. E molti lati del suo carattere per niente facile suggerivano un’ostinazione, una rigidità da regno minerale. A patto di ricordare, con i vecchi alchimisti, che non esiste in natura nulla di più psichico delle pietre e dei metalli. Rafforzavano di sicuro questa impressione la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati. Folta e compatta, la massa inamovibile dei capelli si sarebbe detta modellata e dipinta sulla testa come quella delle marionette. In venticinque anni che l’ho frequentato, sui quarantasei della sua vita, mi sembra che sia rimasto sostanzialmente uguale, come se l’esperienza – questa spietata e sbadata matrigna – non avesse lasciato tracce visibili su di lui. Forte di braccia, gran camminatore, da ragazzino era stato cintura nera di judo. Amava fare, di questa nobilissima arte, certe estemporanee e pericolose dimostrazioni. Ed era davvero impossibile spostarlo, se piantava i piedi a terra come aveva imparato in quei lontani allenamenti sul tatami. Solo negli ultimi anni, il litio che prendeva lo aveva appesantito, ma senza mai fargli perdere del tutto quel suo aspetto tosto, agonistico. Sempre più che sobrio nel vestire. Anche le innocenti losanghe di un maglione erano capaci di metterlo un po’ in imbarazzo, mi ha confidato una volta. Così come esiste l’orrore del vuoto, certi individui patiscono una vera e propria fobia dell’ornamento. Nell’ultima casa abitata a Roma, quella di Monteverde Vecchio, in una palazzina moderna di via Lorenzo Valla, non c’era nemmeno più un quadro, una qualsiasi immagine sulle pareti candide. I mobili erano ridotti all’essenziale. Gli piacevano i legni scuri, i rivestimenti di cuoio. Tutto ciò che esprimeva un’idea dello spazio e della presenza umana in maniera dimessa, priva di eloquenza. Mi ricordo di una mattina d’estate che eravamo a Parigi e ci siamo dati appuntamento davanti al Musée d’Orsay. Era il 1995, e da poche settimane lo Stato francese era entrato in possesso dell’Origine del mondo di Courbet. L’ultimo proprietario privato di quel quadro dalla vita avventurosa era stato Jacques Lacan, che si divertiva, dice la leggenda, a intrattenere i suoi ospiti (o i suoi pazienti?) con una specie di rituale di svelamento. Rimuoveva la copertura che custodiva il quadro difendendolo da sguardi importuni scandalizzati o lascivi, ed eccola lì, la fonte di tutte le cose, la porta della vita: tra due cosce ben tornite e divaricate, la fessura umida, quasi dischiusa, ricoperta della sua peluria fulva, dipinta con tanta sapienza, con tanta venerazione, che sembra quasi emanare il suo dolciastro, inebriante profumo di frutta lievemente marcita. Quando avevano consegnato ufficialmente il capolavoro al Musée d’Orsay, il povero ministro della Cultura francese, cattolico ed ex sindaco di Lourdes, costretto a partecipare alla cerimonia, si era prodotto in contorsioni degne di un equilibrista per evitare di essere immortalato dalle TV in compagnia di quella fica così capace, nonostante il freno dell’arte, di suggerire pensieri peccaminosi. Tra le opere di dimensioni immense che occupano le pareti della sala dei Courbet al pianterreno del museo l’Origine, con la sua cinquantina di centimetri per lato, può sembrare addirittura minuscola: un effetto simile a quello del Cristo morto di Mantegna a Brera – per parlare di un altro capolavoro della pittura nel quale il sacro esplode dalle dimensioni ridotte. Rocco era estasiato. Con noi c’era anche Pia Pera, la nostra adorata Pia, che quando eravamo tutti e tre insieme spendeva sempre una discreta parte delle sue energie per far sì che non iniziassimo, io e Rocco, a litigare per i soliti futilissimi motivi. Ma di quella mattina ho un ricordo luminoso, la vita pareva ancora nasconderci qualche promettente segreto, ed era come se il maestro avesse appena terminato il suo capolavoro apposta per noi, con un ultimo tocco leggero di pennello. Come dicevo, Rocco era il più rapito. Me ne parlava, a distanza di anni, come di una rivelazione estetica suprema e anche di una data importante nella nostra amicizia. Della potenza erotica di quell’immagine, però, dei suoi sottintesi filosofici e naturalistici, non gli importava assolutamente nulla. Era semmai l’assenza di spessore del segno ad affascinarlo: la trasparenza del legame fra l’oggetto e i mezzi della sua rappresentazione. In altre parole, quella che si può definire la suprema libertà di Courbet: che non consiste nel dipingere una fica socchiusa così com’è, in tutta la sua carnale evidenza, ma nel farlo senza ombra di retorica. Si ha un bel dire che quella trasparenza, quella libertà sono a loro volta degli artifici e dunque delle utopie: Rocco, che era il contrario di uno scemo, ne era consapevole, eppure aveva bisogno di muoversi verso l’essenza, il nitore, la concentrazione, la coincidenza più stretta possibile del nome e della cosa. Del senso esatto delle parole, mondate di tutta la loro possibile ambiguità, e dei vincoli morali di questa esattezza, nutriva un bisogno che definirei disperato («cosa intendi?», «perché dici così?», «perché ridi?»). Chi lo conosceva, sapeva che in ballo c’era qualcosa di più profondo, necessario e vincolante di un certo gusto artistico o letterario. Le Furie che lo braccavano da quando era al mondo, fra tregue e nuovi assalti, prosperavano nel manierismo, nella complicazione, nell’incertezza dei segni e dei loro significati. Testardamente, lui cercava di semplificare, di ripulire. Se l’anatomia umana glielo avesse consentito, si sarebbe spesso e volentieri lucidato le ossa e i nervi con uno spazzolino di ferro.