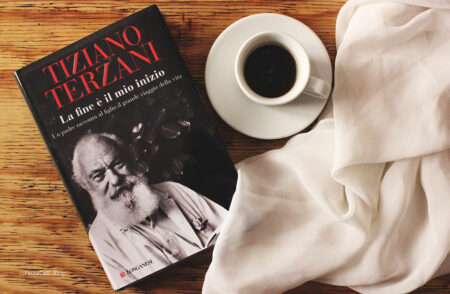Disperanza è un libro scritto da Giulio Cavalli, pubblicato nel 2020 da Fandango. Una riflessione coraggiosa su un male silenzioso del nostro tempo, una luce puntata sul diritto di essere fragili.
“I disperanti decidono di proteggersi, proteggersi all’estremo, di diventare guscio che scivola sulla propria vita e sanno che ogni apertura significherebbe un inevitabile sanguinamento. Anche gli amori dei disperanti sono amori diversi, guardinghi, terrorizzati, spillati con parsimonia, vissuti sempre con il paracadute aperto per prevenire un tonfo, raccontati più che vissuti, inchiodati in uno stallo di incertezza che ci si augura rimanga così per il futuro.”
I disperanti sono uomini e donne del nostro tempo, giovani che non si aspettano niente, che credono nell’occasione e non nell’opportunità, adulti che hanno reso le armi ma non possono permettersi di abbandonare la lotta, cittadini sempre in transito di una società che ci spinge a essere inevitabilmente ottimisti, positivi e performanti. È possibile individuare il momento in cui abbiamo perso la speranza? Quali sono i motivi, lavorativi, personali, di salute, politici che ce l’hanno fatta smarrire? Oggi si possono ancora dichiarare senza vergogna le nostre fragilità contro la retorica del superomismo?
“Figuratevi un uomo chiedere l’elemosina con un cartello Sono maniaco compulsivo, aiutatemi, e i risolini che ci sarebbero nei passanti, quegli stessi passanti che si flettono di fronte a un arto mancante con strazio esibito. Essere depressi spesso significa essere considerati dolenti, nolenti, gozzovigliatori dell’ozio, sfaticati, simulatori. Se vi va bene vi reputeranno semplicemente deboli, ma è già una posizione di privilegio. E invece bisogna essere forti, bisogna essere vincenti, bisogna essere sempre primi o nel gruppo dei primi, bisogna essere perfetti, belli, empatici, simpaticamente antipatici, eleganti, con la risposta sempre pronta, con le dita affusolate, con i pantaloni corti alla giusta lunghezza, con le camicie inamidate, con il sorriso sempre cortese, con buona educazione sempre impomatata, con il fisico tornito, reggere bene l’alcol, capire tutte le battute, fare solo battute che capiscano tutti e ultimamente essere anche politicamente corretti, mentre il depresso è bolso, sciatto, unto, affaticato nell’abbigliamento, non profumato, arruffato e con la barba molle oltre che lunga, pronuncia battute che non capisce nessuno e che sono cattive e offensive, trascina i piedi e non saluta più. Il depresso è l’esatto opposto del modello di persona instagrammabile e da taggare sui social, è l’amico da nascondere per non venire additato come untore. E la malattia così si condisce di solitudine, la solitudine aumenta la discrepanza tra il disperante e il mondo, e accresce la sua voglia di isolamento e la sua arrabbiatura contro i normali che non sono disperanti come lui.”
Disperante è Giulio Cavalli, che a partire dalla propria esperienza personale, una mattina decide di chiedere sui suoi social “vi è mai capitato di perdere la speranza? Se sì in che occasione, come avete fatto a recuperarla?” ed è stato sommerso da una quantità enorme di risposte, soprattutto di persone che trovano difficoltà nel raccontare le proprie fragilità.
La disperanza non è disperazione, ma piuttosto di un’assenza di speranza, è uno stato che si insinua subdolo fino a restare lì, raffermo. Un processo di sottrazione lenta, si comincia con il ridimensionare sogni e progetti, con la perdita graduale di euforia, raggiungendo uno stato di rassegnazione che trasforma l’individuo da protagonista della propria vita ad apatiche comparse.
“Nei momenti in cui tutto sembra sul punto di crollare improvvisamente gli invisibili mostrano quanto siano fondamentali, anche se silenziosi e nascosti. Quel sorriso è la mia carezza quotidiana, è il mio cordone ombelicale con il mondo che c’è lì fuori. Lui non lo sa ma è il mio ossigeno quotidiano. Se è classe dirigente quella che ha il potere di modificare il nostro quotidiano, allora la mia classe dirigente è quel camioncino che passa tutte le mattine e quella voce che mi avvisa, sto arrivando, mi dice. Ci sono mestieri che attraversiamo senza nemmeno accorgercene, li incrociamo per strada e non catturano nemmeno per un istante il nostro sguardo. Sono i mestieri che stanno tenendo in piedi questo paese e che lo tenevano in piedi anche prima del virus. Sono i cosiddetti lavori bassi e invece quanto siamo bassi noi quando iniziamo a dare per scontata anche la fatica delle persone.”
Ho letto questo libro appena è stato pubblicato, seguo Giulio Cavalli da tanto e so che è una garanzia, mi arricchisce sempre, però non sono riuscita a fare una recensione, l’ho rimandata ad oltranza fino ad oggi, e non so perché proprio oggi. Non riuscivo a riordinare le idee e metterle per iscritto, c’era troppo da dire e troppe corde personali sono state toccate da non riuscire a trovare un equilibrio, cercavo una giusta distanza e nello stesso tempo trasmettere tutto il tumulto generato.
Più volte ho attraversato stati di disperanza ed uscirne diventa sempre più facile, primo perché oggi sono consapevole che è già successo, che è passato, che forse ritornerà e che molto probabilmente mi serviva.
Quando capita sento come se il fuoco che mi alimenta, comincia ad affievolirsi, sembra spegnersi, sembra che non si salvi nemmeno una scintilla, adesso so che, come sotto una brace che sembra spenta, lui è lí, che cova, che aspetta il momento giusto per divampare nuovamente.
Come lo stesso Cavalli scrive nel libro, ci vorrebbe “Una cassetta degli attrezzi per architettare la speranza”. Uno di questi attrezzi è la condivisione, nascondere i nostri disagi, le nostre fragilità, non fa altro che dargli più forza. E possiamo usare i social “per seminare umanità“, per affermare il nostro diritto di essere fragili, “Il diritto di cittadinanza delle fragilità andrebbe scritto nella Costituzione”. Ci sprona a non credere a quelli che ci dicono che non ci sono alternative, a quelli che, al contrario e spesso lo fanno per il nostro bene, ci spronano alla reazione senza rendersi conto che ci fanno sentire sbagliati e non hanno rispetto dei nostri tempi, di non credere a quelli che vi propongono la speranza come soluzione, “perché la speranza senza azione e senza la possibilità di materializzarsi in opportunità è un sacco vuoto, una droga stordente che funziona solo come normalizzatrice dell’umore”, a non credere ai nostri pensieri, la mente mente, soprattutto a quei pensieri di paura, svalutazione, senso di colpa, che cercano si impossessarsi della mente e diventare ossessivi, e quindi di non credere nemmeno alla disperanza, non permettergli di diventare permanente, di non credere ai finti umili, agli ostentatori di felicità, ai sempre simpatici. E allora in cosa dobbiamo credere? In noi, dobbiamo essere i primi a rispettare le nostre fragilità. Ci sono molte citazioni in questa recensione e se avessi dovuto condividere tutto quello che ho sottolineato in questo libro mi denuncerebbero, non mi resta che consigliarlo e chiudere con una frase che mi accompagna da sempre. “Siate gentili con tutte le persone che incontrate. Sempre. Ognuno sta combattendo una sua battaglia personale.”
Un’esperienza personale
Soffro di depressione da più di dieci anni. Va e torna. Ogni tanto scompare improvvisamente e ogni tanto arriva velenosa e sottile, non facendosi vedere, quando trova socchiusa qualche porta sul retro. Nei periodi di buio la disperanza è una compagna molle che mi si attacca addosso, qualcosa contro cui è impossibile combattere perché mi è quasi consolatorio averla. Subisco mattine che mi chiedono solo che sia presto sera, scrivendo per mestiere me la ritrovo negli articoli o nei libri come quel brutto alone che lasciano le tazzine di caffè sui fogli. Muoio tutti i giorni, mi accade preferibilmente di notte, comunque nel sonno, anche di pomeriggio se mi addormento davanti a un film stagnante o sotto un brutto libro che mi cade sulla faccia. Muoio liscio, senza intoppi e senza sorprese: è una morte puntuale e quotidiana come il pane che finisce, una morte ordinata come una fila di scolari in gita. Non è un incubo, l’ho chiamato incubo per anni ma è una definizione zoppa, non ci sono le parole per la morte nel sonno di cui muoio io, forse c’è una spiegazione medica ma gli psicologi che me ne parlano provano goffamente ad annacquarla e gli psichiatri l’affrontano proponendo qualche stordente chimico: dicono che, per non morire tutti i giorni, mi basterebbe semplicemente essere un po’ meno vivo tutti i giorni, volare più basso così la caduta non sarebbe più un tonfo, ma semplicemente un inciampo. Muoio rivivendo la morte come me la programmavo quando ero una crosta nel letto. In quel periodo morivo anche da sveglio, credetemi è una bella seccatura, ma allora l’avevo deciso io, la minaccia dinoccolata era uscita direttamente dalla porta scricchiolante della mia testa e poi mi si era incagliata sotto la lingua, non avevo il coraggio di dirmelo, figurarsi di dirlo agli altri, ed è andata a finire che l’ho raccontato solo quando mi è passata.
Se mi è passata.
La morte che mi fa morire tutti i giorni invece mi arriva nel sonno, anche nel semi-sonno quando immobile mi mimetizzo con il resto del mondo su cui sono seduto, mi monta in un incubo avviluppato sul tronco del mio dormire e poi mi riempie la bocca e gli occhi fino al momento in cui mi sveglio. Mi sveglio e mi sbrodola fuori, un rigetto. Così quando apro gli occhi, non è mica uno zero, come un normale ridestarsi, ma mi tocca ripartire da un conto negativo, da un fuorigiri che sbiella tutte le corde del cuore e ogni volta è la stessa storia: prima devo trovare uno spiffero per farci passare almeno un sorriso che basti per ossigenare un po’ di coscienza, poi le vertigini guardando indietro il buco in cui sono finito, poi il tentativo – goffo e patetico – di dirmi che è solo un incubo. Un incubo, non vorrai mica credere al panico degli incubi?, mi dico, e invece no perché l’incubo è un incubo ma il panico è realissimo, poi mi ripeto che sarà il caso, sarà un caso, i brutti sogni succedono e ce lo insegnano fin da piccoli, ma un caso che accade tutti i giorni è un accidente quotidiano e un accidente quotidiano è una regola che non si ha il coraggio di riconoscere. Poi allora me la gioco sulla consuetudine, dovrei essere abituato no?, certo che sì, ma figurati se puoi abituarti a morire tutti i giorni, siamo stati fatti per morire una volta sola, una morte più o meno riuscita e teatrale, magari con la paura di morire tutta la vita, ma morire tutti i giorni è contro natura non c’è sofismo che funzioni, poi mi osservo sparpagliato in giro e mi ricucio i brandelli, sono una bambola di tessuti diversi recuperati con un po’ di fortuna, ogni volta ho un pezzo preso da qualche morte precedente e infine ricomincio a scalarmi dai piedi fino alla punta del naso per tornarmi a galla.
Un capodanno pestifero e quotidiano. Mi proteggo odiando tutti gli altri e odiandomi per il tanto odio. Solo dopo comincio a riconoscere quelli vicini. Per l’amicizia ci vuole una ventina di minuti. Per gli amori almeno un’ora. Cagionevole, reimparo a camminare, leggere, grattarmi, parlare, mangiare, ascoltare. Fidarmi di nuovo non sempre mi riesce.
Sono un mostro zoppo, sopportabile solo nelle punte di questa curva che disegna il mio tempo e che ha i picchi nel punto più alto della ripresa prima di addormentarmi di nuovo e ha il suo punto più basso nella bocca impastata a fine torpore.
Muoio tutti i giorni. Non è nemmeno troppo male. Basta farci l’abitudine e non dirlo a nessuno. Finché funziona. Faccio i conti con la speranza da tempo, con la speranza di non volermi più fare male e con la sensazione futile di essere un caso raro seppur nella bruttezza. Il primo passo per uscirne è riconoscersi non solo. Non è questione di compagnia intesa come comunità ma è la compagnia della comunanza: c’è un mondo che striscia in fondo alla brace tiepida del quotidiano che ha le stesse ferite, gli stessi segni e li indossa nascondendoli. Mostrarli, conoscersi e soprattutto riconoscersi è il primo bivio da imboccare con cura.