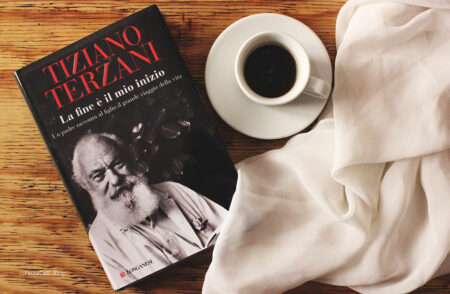Storia di una capinera di Giovanni Verga è un breve romanzo epistolare, sotto forma di monologo, tutte le lettere sono scritte dalla protagonista, che condivide le sue confessioni più intime della sua anima. E’ un capolavoro della letteratura italiana che continua a suscitare emozioni intense e offre uno sguardo penetrante sulle complessità dell’animo umano, uno sguardo delicato e profondo nell’animo di una giovane ragazza costretta alla clausura in un convento.
“ho il cuore così pieno che senza accorgermene cedo al bisogno di comunicarti tutte le nuove emozioni che provo. Nei primi giorni che uscii dal convento e venni qui, ero sbalordita, astratta, trasognata, come trasportata in un mondo nuovo; tutto mi turbava, tutto mi confondeva. Immaginati un cieco nato che per miracolo riacquisti la vista! “
Il romanzo è stato scritto nel 1869, durante il suo soggiorno a Firenze, nel 1870 fu pubblicato a puntate sulla rivista “il Corriere delle dame”, dopo nel 1871, all’interno della rivista di moda La ricamatrice e poi in volume. E’ considerato il primo vero successo editoriale di Verga.
Trama di “Storia di una capinera”
Maria, la giovane protagonista, ha perso sua madre quando era ancora molto piccola ed è stata trasferita in un convento a Catania all’età di sette anni. La sua famiglia, a causa di difficoltà economiche, l’ha costretta a diventare una monaca di clausura. Suo padre, un impiegato modesto che si è risposato e ha altri due figli, non è in grado né di sostenerla né di affrontare le spese necessarie per organizzare un matrimonio, come era consuetudine all’epoca.
Tuttavia, durante un’epidemia di colera che ha colpito la città siciliana nel 1854, Maria ha l’opportunità di trascorrere un breve periodo con la sua famiglia a Monte Ilice. In questo contesto, sperimenta momenti di felicità, esplora le bellezze del mondo esterno e affronta l’ansia del ritorno al convento.
Durante questo periodo, Maria fa la conoscenza di Nino, il figlio dei vicini, e sperimenta un sentimento completamente nuovo: l’amore. Questa scoperta getta Maria in una profonda crisi esistenziale, poiché il suo destino sembrava essere sempre quello di diventare suora.
Tutto questo viene confidato all’amica Marianna, una consorella che si trasferisce anche lei presso la famiglia durante l’epidemia. Marianna decide di non tornare in convento, aumentando ulteriormente la depressione di Maria per un gesto che lei stessa non ha il coraggio di compiere.
“Come son felice, mio Dio! Ti rammenti di Rosalia la quale voleva provarci che il mondo fosse più bello al di fuori del nostro convento? Non sapevamo persuadercene, ti ricordi? e le davamo la berta! se non fossi uscita dal convento non avrei mai creduto che Rosalia potesse aver ragione. Il nostro mondo era ben ristretto: l’altarino, quei poveri fiori che intristivano nei vasi privi d’aria, il belvedere dal quale vedevasi un mucchio di tetti, e poi da lontano, come in una lanterna magica, la campagna, il mare e tutte le belle cose create da Dio, il nostro piccolo giardino, che par fatto a posta per lasciar scorgere i muri claustrali al disopra degli alberi, e che si percorre tutto in cento passi, ove ci si permetteva di passeggiare per un’ora sotto la sorveglianza della Direttrice, ma senza poter correre e trastullarci… ecco tutto!”
La scelta del titolo
La decisione di scegliere questo titolo è collegata a un aneddoto narrato dallo stesso Verga nella prefazione del libro. Verga racconta di aver tratto ispirazione da una capinera, un piccolo uccello, che un giorno vide rinchiuso nella sua gabbia, triste e malinconico, mentre osservava gli altri uccellini liberi di spiccare il volo. Mancando della determinazione necessaria per cercare di liberarsi, la capinera alla fine si lasciò morire di fame e sete.
“Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malaticcia ci guardava con occhio spaventato; si rifuggiva in un angolo della sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che cinguettavano sul verde del prato o nell’azzurro del cielo, li seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi, le volevano bene, cari bambini che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con miche di pane e con parole gentili. La povera capinera cercava rassegnarsi, la meschinella; non era cattiva; non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di beccare tristamente quel miglio e quelle miche di pane; ma non poteva inghiottirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigione.
Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino era pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa oltre la fame e la sete.
Allorché la madre dei due bimbi, innocenti e spietati carnefici del povero uccelletto, mi narrò la storia di un’infelice di cui le mura del chiostro avevano imprigionato il corpo, e la superstizione e l’amore avevano torturato lo spirito: una di quelle intime storie, che passano inosservate tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, che aveva amato e pianto e pregato senza osare di far scorgere le sue lagrime o di far sentire la sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo dolore ed era morto; io pensai alla povera capinera che guardava il cielo attraverso le gretole della sua prigione, che non cantava, che beccava tristamente il suo miglio, che aveva piegato la testolina sotto l’ala ed era morta.
Ecco perché l’ho intitolata: Storia di una capinera.”
Un romanzo in parte autobiografico
Il romanzo prende spunto da un periodo della vita di Giovanni Verga e precisamente all’estate 1854 quando, in seguito all’epidemia di colera che si era scatenata su Catania, la famiglia Verga si rifugia a Tebidi, una località di Vizzini, vicino al monastero di San Sebastiano dove si trova una sua zia monaca. Verga, che aveva allora quindici anni, si innamora di Rosalia, un’educanda del monastero, che lui stesso ricorda come il suo primo amore.
“Signore! grazie! grazie! mi sento rinascere; mi sento purificare dal vostro perdono. Ho pianto, ho pregato tanto, che la mia miseria vi ha fatto compassione; adesso son rassegnata, son tranquilla; non voglio più pensare, non voglio rimaner più sola; il pensiero è il nostro male, la nostra tentazione. Non ti scriverò più, Marianna, poiché per scriverti dovrei rammentare… non voglio più rammentarmi di te, di mio padre, di nessuno!… Perdonatemi, miei cari… il cuore è un gran pericolo… Se ci potessimo strappare il cuore, saremmo più vicini a Dio!”
Recensione
La mia conoscenza di Verga risale ai tempi della scuola ed è stato un incontro del tutto spiacevole, ricordo solo la costrizione di leggere “I malavoglia”, “Rosso Malperlo”, “La Roba” e “Mastro-don Gesualdo”, che mi hanno solo lasciato tanta tristezza e pessimismo, non è riuscito a scalfire la mente di un adolescente, a differenza di quanto ha fatto Pirandello. Non credo che a 14 anni si è pronti per capire opere del genere.
Questa premessa serve per capire con che animo mi sono approcciata a questa lettura di cui conoscevo la storia, ma affrontare Verga, che nella mia testa era veramente un autore pesante, è tutta un’altra storia.
Con mia grande sorpresa questo romanzo mia ha toccato l’anima e mai avrei immaginato che un uomo potesse descrive in modo così perfetto i sentimenti di una donna, men che meno avrei mai pensato a Verga. Riesce a raccontare l’intimo emozionale e psicologico nascosto dentro questa ragazza, che affronta tutto in totale solitudine, con delicatezza, sensibilità e realismo.
Questo romanzo è un inno alla preziosità della libertà che noi spesso diamo per scontato. Maria non muore per amore, ma d’amore, amore per la vita, per la libertà.
E’ una storia drammatica e invisibile al tempo, quante Marie ci sono state. Infatti in quest’opera c’è una chiara e forte denuncia sociale, è un attacco allo status della famiglia dell’epoca, ma è un attacco soprattutto al silenzio dei conventi che accettavano le monacazioni forzate.
Mi ha colpita anche la famosa “cella della pazzia” che esisteva nei conventi, dove venivano messe le monache che impazzivano, che non reggevano psicologicamente a tale prigionia, e se c’erano queste celle significava che era un fenomeno frequente e prevedibile, e quindi evitabile, infatti Verga ne sottolinea in un passo “tradizione del convento che quella cella non debba rimanere vuota”.
Un libro struggente, doloroso, intimo, ma che consiglio. Dopo questa esperienza, ho l’intenzione di riprendere in considerazione anche le altre opere di Verga, sperando in una rivalutazione dell’autore.
Una della parti che più mi ha colpito è la cerimonia con la quale Maria prende definitivamente i voti, a cui è presente tutta la sua famiglia e dunque anche Nino, in qualità di marito di Giuditta.
“Lunedì, 7 aprile.
Sorella mia! Hai udito mai i defunti parlare dalla tomba?
Son morta! La tua povera Maria è morta. M’hanno disteso sul cataletto, m’hanno coperto del drappo mortuario, hanno recitato il requiem, le campane hanno suonato… Mi pare che qualche cosa di funereo mi pesi sull’anima, e che le mie membra sieno inerti. Fra me e il mondo, la natura, la vita, c’è qualche cosa di più pesante di una lapide, di più muto di una tomba.
È uno spettacolo che atterrisce! La morte fra il rigoglio della vita, fra il tumulto delle passioni, il corpo che vede morire l’anima, la materia che sopravvive allo spirito!
Apro gli occhi come trasognata; spingo lo sguardo nell’immensità, fra quel buio, quel silenzio, quella quiete inerte… Tutto è ad una immensurabile distanza. Ti vedo come in sogno, al di là dei confini della realtà… Sei tu che sei svanita nel vuoto, oppure son io che mi sono smarrita nel nulla?
Sono ancora sbalordita. Mi pare di aggirarmi in un immenso sepolcreto, mi pare che tutto ciò sia un sogno… che non debba essere per sempre, che io debba svegliarmi. Ho assistito ad uno spettacolo solenne, ma mi pare che non sia stato per me… Mi pare che io sia stata presente come tutti gli altri ad un funerale, ad una lugubre cerimonia religiosa, ma che quando tacerà quella musica, quando non suoneranno più quelle campane, quando si spegneranno quei ceri, quando quei preti sfileranno in sagrestia, quando tutta quella gente si leverà per andarsene, debba andarmene anch’io e non abbia a restare sola, qui… dove ho paura… Ho visto tutti quei lugubri apparecchi che stringono il cuore, e si trattava di me?… ed ero io che morivo?… Tutta quella gente vestita a festa, tutti quei suoni, tutti quei lumi erano per me?… Ed io ho potuto acconsentire a morire?… Ho voluto morire?…”
Incipit di “Storia di una capinera”
Monte Ilice, 3 settembre 1854.
Mia cara Marianna.
Avevo promesso di scriverti ed ecco come tengo la mia promessa! In venti giorni che son qui, a correr pei campi, sola! tutta sola! intendi? dallo spuntar del sole insino a sera, a sedermi sull’erba sotto questi immensi castagni, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano come me e ringraziano il buon Dio, non ho trovato un minuto, un piccolo minuto, per dirti che ti voglio bene cento volte di più adesso che son lontana da te e che non ti ho più accanto ad ogni ora del giorno come laggiù, al convento. Quanto sarei felice se tu fossi qui, con me, a raccogliere i fiorellini, ad inseguire le farfalle, a fantasticare all’ombra di questi alberi, allorché il sole è più cocente, a passeggiare abbracciate in queste belle sere, al lume di luna, senz’altro rumore che il ronzìo degli insetti, che mi sembra melodioso perché mi dice che sono in campagna, in piena aria libera, e il canto di quell’uccello malinconico di cui non so il nome, ma che mi fa venire agli occhi lagrime dolcissime quando la sera sto ad ascoltarlo dalla mia finestra. Com’è bella la campagna, Marianna mia! Se tu fossi qui, con me! Se tu potessi vedere codesti monti, al chiaro di luna o al sorger del sole, e le grandi ombre dei boschi, e l’azzurro del cielo, e il verde delle vigne che si nascondono nelle valli e circondano le casette, e quel mare ceruleo, immenso, che luccica laggiù, lontan lontano, e tutti quei villaggi che si arrampicano sul pendìo dei monti, che sono grandi e sembrano piccini accanto alla maestà del nostro vecchio Mongibello! Se vedessi com’è bello da vicino il nostro Etna! Dal belvedere del convento si vedeva come un gran monte isolato, colla cima sempre coperta di neve; adesso io conto le vette di tutti codesti monticelli che gli fanno corona, scorgo le sue valli profonde, le sue pendici boschive, la sua vetta superba su cui la neve, diramandosi pei burroni, disegna immensi solchi bruni.
Tutto qui è bello, l’aria, la luce, il cielo, gli alberi, i monti, le valli, il mare! Allorché ringrazio il Signore di tutte queste belle cose, io lo faccio con una parola, con una lagrima, con uno sguardo, sola in mezzo ai campi, inginocchiata sul musco dei boschi o seduta sull’erba. Ma mi pare che
il buon Dio debba esserne più contento perché lo ringrazio con tutta l’anima, e il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si stende per le ombre maestose di questi boschi, e per tutta l’immensità di questo cielo e di quest’orizzonte. Ci chiamano le elette perché siamo destinate a divenire spose del Signore: ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose dovrebbero esserne prive?