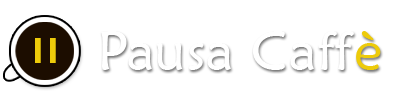Nel tempo sospeso della violenza.
C’è un momento, sempre, in cui tutto è ancora possibile, in cui la paura non ha nome ma pulsa forte nel petto, in cui si percepisce il pericolo ma non abbastanza da gridare, in cui si racconta un disagio ma non abbastanza da farlo ascoltare.
È lì che si annida la violenza più silenziosa, quella che non fa rumore, che non ha cicatrici da mostrare, che non ha testimoni.
È lì che inizia, molto prima di diventare reato, molto prima di diventare sangue.
Sara Campanella aveva ventidue anni. Studiava, costruiva il suo futuro, coltivava sogni e affetti come ogni giovane donna. Aveva intuito qualcosa — lo aveva detto a un’amica: “Mi sta seguendo.” Non era un ex, non era un fidanzato. Solo un collega, troppo presente, troppo vicino, troppo spesso.
Quel giorno, alla fermata dell’autobus, Sara era stanca. Aveva chiesto aiuto, in un modo che non sapeva ancora chiamare “denuncia”.
Aveva percepito che quel disagio si stava trasformando in minaccia, ma nessuno l’ha fermato. Nessuno l’ha fermata, quella violenza.
E allora ci resta il dovere di tornare a guardare proprio lì, in quel tempo sospeso dove tutto inizia e nulla viene preso sul serio, nel confine sottile tra il disagio e il pericolo, tra il fastidio e la ferita, tra ciò che si intuisce e ciò che si crede. Perché finché non diventa sangue, troppo spesso non diventa nulla.
La cronaca che conosciamo
Messina, 31 marzo 2025. Ore 13:00 circa, viale Gazzi.
Una fermata dell’autobus, poco distante dallo stadio “Giovanni Celeste”.
Una ragazza, una studentessa, una presenza luminosa in mezzo alla frenesia del giorno.
Sara Campanella aveva ventidue anni. Studiava Infermieristica all’Università di Messina, era originaria di Misilmeri. Una vita che si preparava a prendersi cura degli altri.
Ad aspettarla, però, non c’era un autobus.
C’era un uomo. Non uno sconosciuto. Non uno che si nascondeva. Un collega, che la conosceva. Uno che la osservava da tempo.
Lui si chiama Stefano Argentino, ventisette anni, di Noto.
Frequentava lo stesso ambiente universitario. Nessuna relazione tra loro, nessuna storia d’amore finita male. Solo un rifiuto, chiaro, costante, reiterato. E da parte sua, un’ossessione. Chi la conosceva lo aveva capito. Qualcuno ha parlato di “attenzioni morbose”, altri di “presenza insistente”. E poco prima dell’aggressione, Sara aveva mandato un vocale a un’amica. Le diceva: “Sono sicura che lui mi sta seguendo.”
Non aveva sporto denuncia. Ma lo aveva detto. Lo aveva intuito. Lo aveva temuto.
Quel giorno, Stefano l’ha raggiunta. L’ha colpita alla gola con un coltello, davanti a testimoni, in mezzo alla strada. È rimasta lì, senza possibilità di difesa, sotto gli occhi increduli di chi, forse, avrebbe voluto intervenire.
Ma era già troppo tardi.
È stato arrestato poco dopo, fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione e motivi abietti. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti e le immagini delle telecamere, aveva pianificato tutto. Nessun gesto improvviso. Nessuna follia momentanea. Solo un’ossessione nutrita nel tempo e lasciata crescere senza argini.
La violenza non comincia con un coltello, non sempre, non solo. A volte comincia con uno sguardo che si ripete, con un messaggio non richiesto, con una presenza troppo costante per essere casuale.
Comincia molto prima che si possa chiamare “reato”.
Sara lo aveva capito. Aveva percepito qualcosa che non funzionava, l’aveva detto a un’amica: “Mi sta seguendo”, e chi le stava accanto sapeva che quella presenza era insistente, che quel ragazzo la cercava, la osservava, da troppo tempo.
Non erano fidanzati, non erano ex, non c’era una storia da interrompere. C’era solo un rifiuto, chiaro e definitivo, e una fissazione che cresceva nell’ombra.
Ma tutto questo, nel nostro sistema, non basta. Non è sufficiente a generare protezione.
Non c’è denuncia se non c’è minaccia esplicita, non c’è tutela se la paura non si può misurare, se il disagio resta nel territorio sfumato delle sensazioni.
Eppure è lì che tutto comincia, nel tempo sospeso in cui si spera di sbagliarsi, nel dubbio che ti frena dal parlare, nella voce che ti sussurra “forse sto esagerando”, mentre dentro sai che no, non stai esagerando affatto.
Questa soglia, così opaca, è anche una soglia culturale, perché è la nostra cultura che ancora oggi fatica a riconoscere la violenza quando non è evidente, che ancora scambia l’insistenza per passione, la gelosia per amore, il controllo per premura.
E quando un “no” non basta a chiudere la porta, quando il disagio viene minimizzato, quando non si sa dove andare per essere credute prima che sia troppo tardi, non siamo più nel territorio dell’ambiguità: siamo già dentro il pericolo.
Messina non è rimasta in silenzio. Nel giro di poche ore, fiori, biglietti e candele hanno iniziato a comparire proprio lì, alla fermata dell’autobus in viale Gazzi, dove Sara è stata uccisa.
Un luogo qualsiasi che, d’un tratto, è diventato simbolico, fragile, sacro. Un altare civile, come ne nascono quando la comunità decide che non può più voltarsi dall’altra parte.
E poi le fiaccolate, i cortei. Da piazza Pugliatti fino al luogo dell’omicidio, passando per l’Università dove Sara studiava e dove, pochi giorni prima, si muoveva tra lezioni e progetti come ogni altra ragazza della sua età. Il corteo era composto da studentesse e studenti, docenti, associazioni, donne e uomini comuni.
Chi c’era racconta un silenzio composto, ma vibrante. Cartelli scritti a mano, passi lenti, sguardi che cercavano parole e, non trovandole, restavano fermi nel rispetto.
Sui social, intanto, il suo nome si moltiplicava:
#SaraCampanella #StopFemminicidio #NonUnaDiMeno
Accanto ai messaggi di dolore, sono apparsi pensieri lucidi, riflessioni necessarie, scritte non con l’urgenza del momento ma con la consapevolezza che ciò che è accaduto a Sara non è un’eccezione.
È il riflesso di una cultura che confonde il possesso con l’amore, che insegna a rincorrere anche quando l’altro si allontana, che tollera l’insistenza finché non degenera.
Una cultura che non prende sul serio i segnali, che non riconosce la violenza se non quando è eclatante, che minimizza il disagio, che fatica a credere alla paura.
E ogni volta che qualcuno prova a chiamarla per nome, questa cultura viene accusata di esagerare, di voler vedere mostri ovunque, di distruggere la normalità. Ma non c’è nulla di normale nella morte di una ragazza che aveva detto “no” e non è stata creduta abbastanza.
Ci siamo abituati a vedere le piazze riempirsi. Fiaccolate, manifestazioni, cartelli, articoli accorati, denunce vibranti. E ogni volta, giustamente, ci diciamo che è doveroso esserci.
Guai se non lo facessimo. Guai se non coltivassimo la memoria e il rispetto per chi è stato portato via, per chi è caduta sotto il peso di una violenza che non ha più argini.
Ma qualcosa, dentro, comincia a stancarsi. Non della rabbia, non della solidarietà. Si stanca di vedere tutto questo accadere ancora.
Perché, nonostante le parole, le veglie, gli appelli, le cose accadono. Ancora allo stesso modo, con la stessa dinamica, con la stessa solitudine, con lo stesso finale.
Non può bastare più.
Non possono bastare gli articoli, e ne sono stati scritti tantissimi, anche profondi, anche giusti, se tutto si ferma lì.
Non possono bastare le fiaccolate, se ogni mese c’è un altro nome da illuminare. Non può bastare un momento di silenzio, se poi tutto torna a scivolare nel rumore dell’abitudine.
Dobbiamo andare più a fondo. Dobbiamo smettere di trattare questi casi come singole tragedie isolate e riconoscerli per ciò che sono: sintomi di una cultura che non è ancora guarita.
Una cultura che va affrontata alla radice, con l’educazione, con la giustizia, con la prevenzione reale, con il coraggio di rimettere in discussione i modelli relazionali, affettivi, maschili, sociali che continuiamo a normalizzare.
Solo così potremo, un giorno, non solo ricordare. Ma anche impedire.
Il tempo che resta.
Non serve raccontare l’orrore, serve ascoltare ciò che lo precede.
Serve imparare a leggere i segnali, a non minimizzare, a non chiedere prove alla paura.
Perché quando finalmente la violenza diventa evidente, spesso è già diventata irreparabile.
Sara non voleva diventare un simbolo, voleva vivere.
E questo, davvero, dovrebbe bastarci.
Articolo di Mariangela Galletta